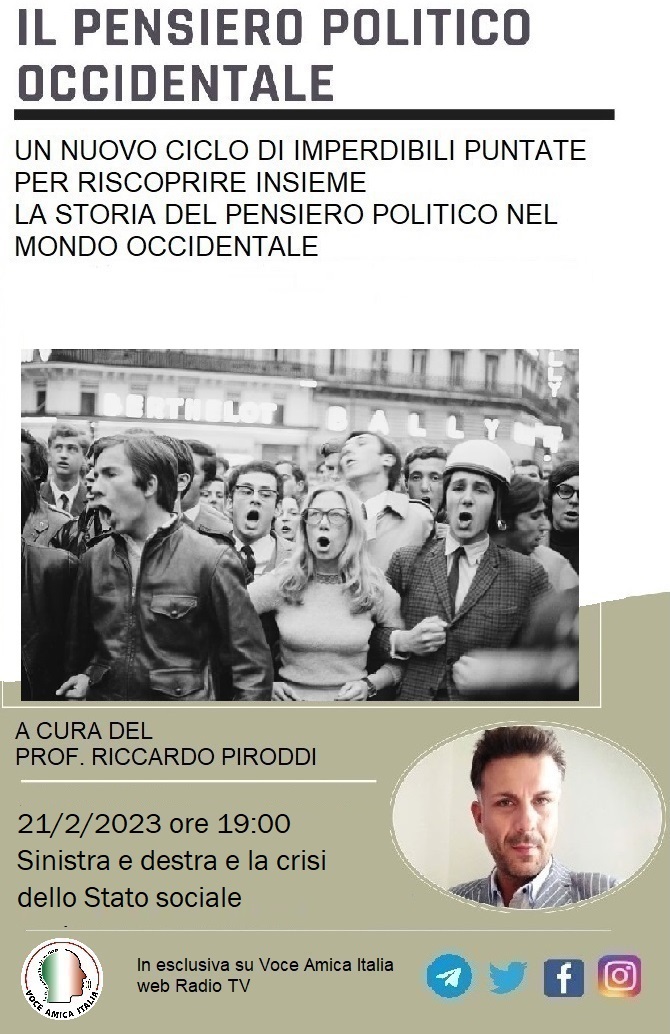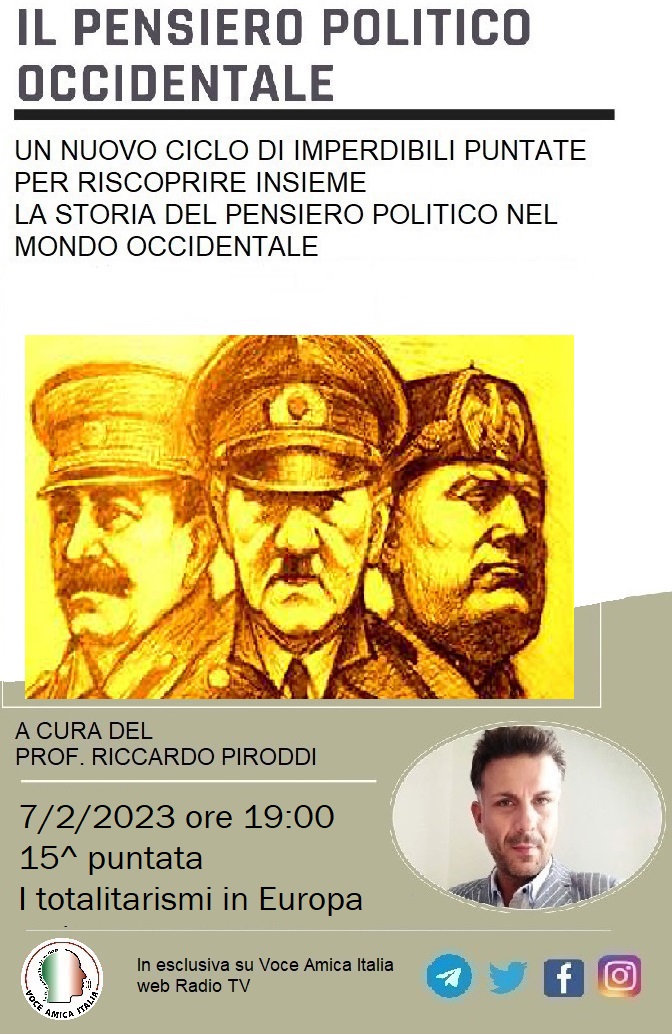di
Riccardo Piroddi*
“Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare. E quando ho visto il mio demonio, l’ho sempre trovato serio, radicale, profondo, solenne: era lo spirito di gravità, grazie a lui tutte le cose cadono. Non con la collera, col riso si uccide. Orsù, uccidiamo lo spirito di gravità. Ho imparato ad andare: da quel momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi. Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di sotto di me, adesso è un dio a danzare, se io danzo”.
Buona sera, buona sera a tutti. Le parole che ho appena recitato non sono mie. Lo fossero, ora sarei nell’olimpo dei pensatori di tutti i tempi. Sono di un personaggio della storia del pensiero universale di cui vi parlerò tra poco. Non ho bisogno di presentarmi, mi conoscete tutti. Mi considero ancora un giovane virgulto, figlio di questa terra meravigliosa, la terra massese. Non è un mistero che, da anni, collabori con il professor Lauro, per cui, di quest’opera che presentiamo stasera conosco anche l’esatta posizione delle virgole. Lo scorso anno, quando, a pochi metri da qui, in piazza, presentammo il romanzo precedente del professor Lauro, “Caruso The Song – Lucio Dalla e Sorrento”, dedicai il mio intervento a donna Violetta. Stasera ella è qui, davanti a me e tra voi, e con il cuore tra le mani voglio dire a lei che sto per offrirle, non soltanto questa mia relazione, ma la mia anima. Avrei voluto tenere, in questa occasione, un discorso nel quale raccontarvi l’incredibile storia che mi ha visto protagonista, in tutte le fasi che hanno portato alla pubblicazione di questo romanzo, dalle interviste a donna Violetta, alle quali ho avuto la gratificante possibilità di partecipare (in qualità di novizio di frate Guglielmo da Baskerville – Lauro, per citare il mio amato Umberto Eco), alla nostra amicizia, la quale è una medaglia d’onore che avrò appuntata sul petto fino alla fine dei miei giorni, sino alle nostre telefonate notturne, sovente in inglese, durante le quali parliamo di William Turner, di Dante Alighieri, di letteratura e delle ultime vicende politiche internazionali. Avrei voluto, ma come mi ha insegnato il filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau, a parlare di sé non si guadagna mai nulla! Ed ecco, allora, che per onorare secondo il massimo delle mie possibilità questa donna straordinaria, ho deciso di indossare i miei abiti migliori, quelli dell’educazione sentimentale e culturale, e di riferirvi talune impressioni suscitatemi da questo bel romanzo, facendomi condurre per mano da uno dei più elevati spiriti dell’umanità, che io sommamente amo e al quale sono enormemente debitore. L’autore delle parole che ho poc’anzi recitato: Friedrich Wilhelm Nietzsche.
Perché mai, proprio Nietzsche? Perché, credetemi, Violetta Elvin e Friedrich Wilhelm Nietzsche hanno molte caratteristiche in comune. Non soltanto il medesimo amore per la danza. In Nietzsche, la danza è attività libera e liberatrice. E’ espressione, insieme con la musica, di quell’elemento dionisiaco oscuro, contrapposto all’apollineo luminoso. Per mostrarvi, dunque, queste caratteristiche comuni vorrei partire dall’occasione che, nel romanzo, mi ha suggerito questo percorso. Monte Comune, Vico Equense: in un afflato di incanto naturalistico, la giovane Violetta, immersa nell’estasi visiva del golfo di Napoli, ripercorre, in pochi attimi, cito: “Il grande cratere di fuoco, il prevalere delle acque, il consolidarsi di quell’armonia, un’opera d’arte, che anche il più convinto agnostico avrebbe faticato a non definire divina. Da quel punto di osservazione del mondo l’epopea della vita, la nascita di Venere pagana, che emerge dalla spuma delle onde, e il destino dell’umanità, tutto diventava più chiaro, intuitivamente, senza avere più bisogno di spiegazioni”.
La giovane Violetta, in quel momento, decide di riprendere in mano la propria vita, di darle una nuova forma e una nuova direzione. Un nuovo inizio, quindi. Una palingenesi.
Sils Maria, Engadina svizzera: in una notte estiva di luna, Nietzsche, mentre passeggia tra i laghetti che bagnano la località alpestre, ha l’intuizione di una teoria destinata a diventare uno dei capisaldi della sua dottrina filosofica: l’eterno ritorno all’uguale.
“Non essendoci un Dio creatore che ha dato inizio a un mondo composto di esseri finiti, allora il mondo non ha né inizio né fine, è eterno ed è composto di esseri infiniti”. “L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere! Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta: Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina”.
Queste ultime sono parole di Nietzsche da “La gaia scienza”, opera del 1882, che scrisse quando aveva pressappoco la mia età e nella quale annunziò proprio questa teoria. Ecco, soffermiamoci un attimo su questa parola: gaia. E’ la chiave che mi ha consentito di rintracciare parallelismi tra le esistenze e la poietica di Violetta Elvin e Friedrich Wilhelm Nietzsche. Mi figuro la vita di donna Violetta come una vita gaia, proprio in senso nietzschiano. Nietzsche scrive “La gaia scienza”, opera che rappresenta il passaggio dalla fase cosiddetta dello spirito libero alle sommità mature del suo pensiero, influenzato da un luogo fisico, dall’ebbrezza della contemplazione di un paesaggio naturale. Allo stesso modo, Violetta opera, in un medesimo contesto spirituale, quella scelta di vita che le permetterà di chiudere un periodo, quello della danza, e di aprirne un altro, quello dell’amore: Dance The Love, appunto.
C’è dell’altro, però, su cui ho costruito la comparazione tra donna Violetta e Nietzsche e riguarda il mio approccio intimo e personale alle vicende dei due: il mio debito di gratitudine nei confronti di entrambi. Nietzsche è stato uno dei massimi formatori del mio pensiero. Io amo Nietzsche perché la sua filosofia è una filosofia gioiosa, una filosofia dello spiritus construens, una filosofia del futuro. Sono solito rispondere in questo modo alla domanda che mi viene spesso posta, riguardo cosa ami parlare quando sono con una donna (i dialoghi con una donna sono, per un uomo, il più meraviglioso esercizio di dialettica della passione!): io amo parlare del futuro. Con le donne io amo parlare del futuro! Questo me lo ha insegnato Nietzsche. Nietzsche ha liberato l’umanità dalle incrostazioni esiziali che la metafisica, da Platone a Hegel, aveva sedimentato nella storia del pensiero occidentale. Il suo celebre adagio, “Dio è morto”, riferibile non soltanto all’ambito religioso, ma, appunto, più in generale, a quello filosofico-metafisico, è divenuto il suono delle campane che hanno destato l’umanità, aprendole gli occhi a una nuova era. Ne “Il crepuscolo degli idoli”, del 1888, il filosofo spiega, in sei punti, come “il mondo vero finì per diventare una favola”, posando, sulla metafisica occidentale, la più ironica e insieme distruttiva, oserei dire definitiva, pietra tombale. Vi consiglio di leggere quest’opera, se siete preparati alla deflagrazione di tutte le vostre credenze. C’è un termine, ricorrente in molti punti dell’opera nietzschiana: antivitale. Egli lo riferisce, particolarmente, alle religioni e ai vecchi sistemi di credenze. Il mio amore per Nietzsche è germogliato grazie a questa parola perché ha saputo palesare cosa fosse e cosa significasse il contrario. Vitale, ciò che abbandona il vecchio e si proietta verso il futuro. L’uomo, infatti, ripudiati i sistemi mentali pregressi, che lo hanno costretto alla schiavitù morale, all’antivitale, adoperata e accettata la trasvalutazione dei valori, per usare la sua terminologia, diviene un essere vitale, proiettato verso il futuro, verso la libertà. Nietzsche ha mostrato a cosa dovessero tendere l’uomo e l’umanità. Nietzsche è stato certamente un uomo pieno d’amore. Un sistema filosofico come il suo ha necessariamente alla base una massiccia quantità di amore. Nella vita, però, da quel punto di vista, fu sfortunato. Amò una sua discepola, Lou Salomé, la quale rifiutò di sposarlo, precipitandolo in una crisi depressiva che, tuttavia, gli fu provvidenziale, in quanto gli ispirò la prima parte di “Così parlò Zarathustra”. E, ancora, nonostante non vi siano prove certe, l’innamoramento, sempre infelice, per Cosima Wagner, seconda moglie del famoso compositore Richard, con i quali, tra l’altro, fu qui, a visitare il monastero del Deserto, negli anni ’80 dell’Ottocento. Un grande uomo, un grande spirito, un’anima libera, un benefattore dell’umanità! Un pensatore cui oggi le giovani generazioni, come la mia, dovrebbero guardare. In un’epoca in cui quanti ci hanno preceduto non hanno lasciato a noi neppure le macerie con le quali poter costruire il nostro futuro, un filosofo il quale, dal punto di vista dottrinario, ha tracciato la via maestra per l’avvenire, deve essere venerato come una divinità! Altro che i falsi miti propinati oggi dai media!
Donna Violetta, adesso questo mio discorso entra nella parte più sentimentale, quella più difficile, per me, da enunciare, perché temo che lacrime di gioia possano rigare il mio viso e occludermi la gola, impedendomi finanche di parlare. Mi rivolgo direttamente a voi, per cercare di chiarire i motivi di questo accostamento della vostra persona e della vostra storia a Nietzsche: Nietzsche filosofo vitale, danzatore dello spirito, uomo d’amore, profeta della libertà, oracolo dell’avvenire. Voi, donna Violetta, artista vitale, danzatrice dello spirito, donna d’amore, profetessa della libertà, oracolo dell’avvenire. Io ho avuto il privilegio di poter ascoltare, dalla vostra viva voce, i racconti della vostra incredibile vita di bambina, di donna, di artista, di moglie e di madre. I lettori di questo bellissimo romanzo lo faranno attraverso le pagine che il professor Lauro ha così bellamente costruito. Per cui, non vi indugio affatto. Donna Violetta, questo intervento è affiorato nella mia mente già mentre, un anno e mezzo fa, vi ascoltavo parlare di voi e della vostra storia. Immediatamente, vi ho legata al filosofo di cui ho esposto. Davanti ai miei occhi incantati di giovane avete portato in scena, come facevate al Teatro Bol’šoj di Mosca o alla Royal Opera House di Covent Garden, nella nostra amatissima Londra, la filosofia di Nietzsche. “Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare!” Donna Violetta, voi sapete danzare, eccome, e io credo in voi. Queste mie riflessioni siano un altare che io innalzo al vostro simulacro, alla vostra vicenda esistenziale, alla vostra bellezza mai sfiorita. La vostra storia è la dimostrazione reale di quel vitalismo di cui parlava il Nietzsche, sostenuto dall’amore per la vita, per la danza, per l’arte, per un uomo, il vostro Fernando, per un figlio, il vostro Antonio, e per una terra, questa nostra Penisola Sorrentina e Vico Equense in particolare, nella quale siete sbocciata come il fiore più prezioso, l’orchidea “Scarpetta di Venere”, la stessa scarpetta che indossavate in teatro, e come la Venere cantata da Foscolo nel sonetto “A Zacinto”, avete fatto feconda, o nella quale, come la Beatrice di Dante, siete venuta a miracol mostrare. Il miracolo della vostra stessa vita, che avete donato a questa terra e a noi, suoi abitanti. Donna Violetta, filosoficamente parlando, avete operato quella rivoluzione, non copernicana, come direbbe Immanuel Kant, ma nietzschiana. Avete superato l’oppressione di un regime dittatoriale, che per Nietzsche era la metafisica, aprendo le vostre ali verso la libertà, verso la vita. Avete fatto diventare quel mondo vero, che Lenin, Stalin e il comunismo avevano costruito, una favola. Anche voi avete operato e accettato la trasvalutazione dei valori, avendo la forza di rinunciare, non come Nietzsche, a qualcosa che vi rendeva schiava, ma ancor più difficilmente, a qualcosa che amavate, la danza, per abbracciare qualcuno che avreste amato ancora di più. Avete conquistato la vera libertà: quella di amare! Siete voi stessa diventata il simbolo della libertà. Donna Violetta, ai miei occhi incantati di giovane, spesso velati dalla malinconia dei poeti, voi siete sole splendente, trasfigurata, nietzschianamente trasvalorata, nel sole. “Vergine bella che di sol vestita”, cantava Francesco Petrarca. Come nelle muse dei poeti, io vedo in voi tutte le donne del mondo, tutte le madri del mondo. Nel vostro cuore c’è la storia del mondo. “Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare!”. Donna Violetta, guardano a voi, così regale, così bella, così meravigliosa, io penso alla donna che, spero, un giorno possa accompagnarmi nella vita e allora, quando l’avrò davanti, regale, bella e meravigliosa come voi, con il cuore e le gambe tremanti, come in questo momento, le dirò, pensando a voi, pensando al vostro esempio, pensando alla delicatezza e all’affetto che avete sempre mostrato nei miei confronti, che nel teatro del tempo io danzerò la mia vita: tu, sole, come luce di scena e l’eternità come sfondo! Grazie donna Violetta! Grazie a tutti!
 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
 Violetta Elvin e Riccardo Piroddi, a Vico Equense, a casa della danzatrice (2016)
Violetta Elvin e Riccardo Piroddi, a Vico Equense, a casa della danzatrice (2016)
* Intervento integrale tenuto alla presentazione del romanzo di Raffaele Lauro, “Dance The Love – Una stella a Vico Equense”, GoldenGate Edizioni, 2016, dedicato alla danzatrice russa Violetta Elvin.
Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli), 28 agosto 2016.