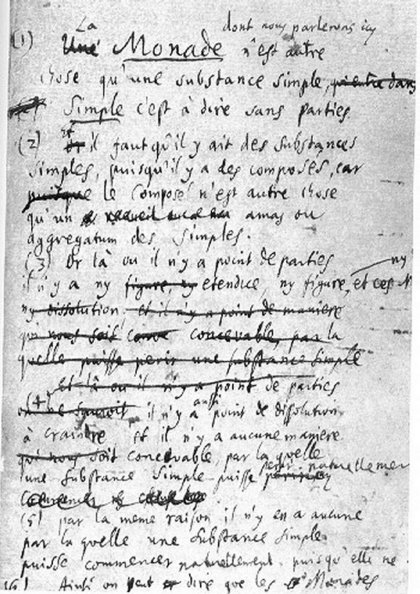Recensione di Riccardo Piroddi
La Cybersecurity nel ‘Metaverso’ di Giuseppe Ferrigno, edito da Eurilink University Press, 2024, presenta un’analisi approfondita e strutturata delle sfide e delle prospettive legate alla sicurezza informatica nei mondi virtuali, un argomento di crescente rilevanza nell’era digitale.
Il testo si articola in dodici capitoli, che esaminano vari aspetti della cybersecurity nel contesto virtuale, iniziando con una panoramica storica e tecnologica, passando per la disamina delle attuali piattaforme e approfondendo le applicazioni e le problematiche specifiche legate alla sicurezza dei dati, dell’identità dell’avatar, dell’economia virtuale e della psicologia cibernetica.
Il capitolo I introduce il lettore ai mondi virtuali, tracciandone la storia e l’evoluzione tecnologica, mentre il II elenca e descrive le principali piattaforme di realtà virtuale in uso oggi, come Second Life, Roblox e Fortnite, evidenziando la loro popolarità e il numero di utenti attivi. Questo capitolo fornisce una base essenziale per comprendere il contesto in cui la cybersecurity diventa rilevante. Nel capitolo III, l’Autore esplora le diverse applicazioni dei mondi virtuali, che spaziano dai luoghi di lavoro virtuali all’istruzione, dai giochi alla socializzazione, fino alla moda e al turismo virtuale. Questo capitolo illustra l’ampio raggio di interazioni e transazioni che possono necessitare di protezione da rischi informatici.
Il cuore del testo si trova nei capitoli dal IV all’VIII, dove si analizzano i quattro layer della cybersecurity nel metaverso: la rete Internet, l’identità dell’avatar, l’economia e la cyberpsychology. Questi capitoli espongono un’analisi dettagliata delle minacce specifiche e delle strategie di mitigazione, ponendo l’accento sulla complessità e l’interdipendenza dei vari aspetti della sicurezza nei mondi virtuali. Il capitolo IX si concentra sulla blockchain e il suo impiego per la gestione della proprietà intellettuale e delle transazioni nel metaverso, argomento che unisce considerazioni tecniche e legali. Gli ultimi capitoli trattano le prospettive future, i problemi normativi aperti e il ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nei mondi virtuali.
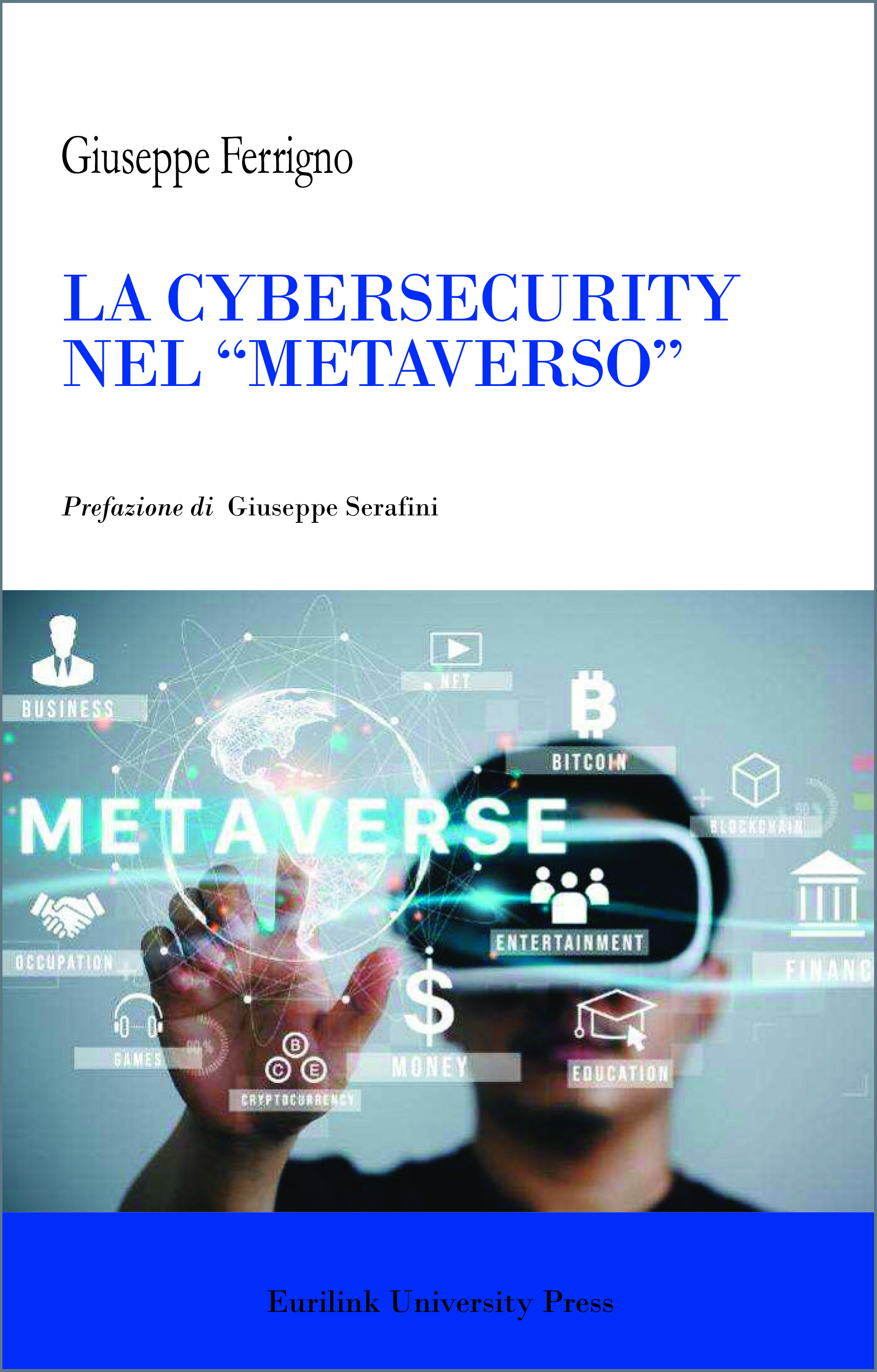
Il volume costituisce un’opera essenziale e tempestiva. Attraverso una disamina dettagliata e meticolosamente organizzata, il testo fornisce un panorama esaustivo delle minacce, delle soluzioni tecniche e delle implicazioni legali legate alla crescente prevalenza dei metaversi nella vita quotidiana.
Una delle principali forze di questo libro è la sua capacità di integrare una varietà di temi – dalla tecnologia blockchain all’identità digitale e alla psicologia cybernetica – in un unico tessuto narrativo coeso. L’Autore riesce a guidare i lettori attraverso la storia e l’evoluzione tecnologica dei mondi virtuali, fornendo un contesto critico che aiuta a comprendere la natura e la scala delle sfide di sicurezza attuali. Questo approccio storico non solo arricchisce la comprensione del lettore ma stabilisce anche una solida base per le discussioni sui moderni aspetti della cybersecurity nel metaverso. Il volume brilla particolarmente quando tratta le specifiche applicazioni dei mondi virtuali. Dall’istruzione al lavoro, passando per il turismo e il sociale, l’Autore indaga come ogni ambito presenti sfide uniche in termini di sicurezza e privacy. Questa analisi multisfacettata non solo aumenta la consapevolezza delle potenziali vulnerabilità ma stimola anche la riflessione su come mitigarle in modo efficace.
Un altro punto di forza significativo del libro è l’esame dettagliato dei “quattro layer” della cybersecurity nel metaverso. Questa strutturazione permette di sondare in profondità le diverse dimensioni della sicurezza, dal livello di rete fino agli aspetti più personali e psicologici. Il trattamento olistico di queste tematiche informa e invita anche a un approccio più integrato e sistematico alla sicurezza nei mondi virtuali.
Il volume, inoltre, offre una riflessione critica sull’uso della blockchain e delle tecnologie associate quali strumenti per la gestione della proprietà intellettuale e delle transazioni sicure nel metaverso. L’Autore presenta una discussione equilibrata sui benefici e sui rischi di queste tecnologie, fornendo una valutazione ponderata che è rara nella letteratura attuale su questi argomenti.
La Cybersecurity nel ‘Metaverso’ è, dunque, un’opera preziosa, che propone un contributo significativo al campo della sicurezza informatica, consegnando un’analisi approfondita e comprensiva che è sia educativa che provocatoria. È una risorsa indispensabile per professionisti della sicurezza, sviluppatori di software, legislatori e quanti siano interessati al futuro della nostra interazione con i mondi virtuali.





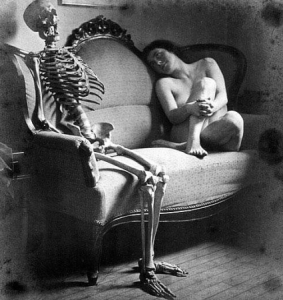

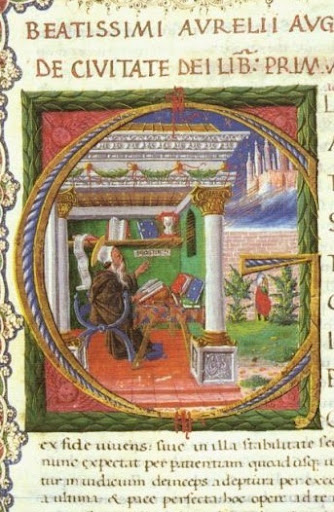 La città di Dio di Agostino, vescovo di Ippona, è un testo fondamentale nella storia del pensiero cristiano occidentale, una difesa del cristianesimo contro le accuse di aver causato il declino di Roma e una profonda riflessione sul destino dell’uomo e sulla storia universale.
La città di Dio di Agostino, vescovo di Ippona, è un testo fondamentale nella storia del pensiero cristiano occidentale, una difesa del cristianesimo contro le accuse di aver causato il declino di Roma e una profonda riflessione sul destino dell’uomo e sulla storia universale.