Quando se ne va un Maestro come Roberto De Simone, non si spegne solo una voce, si abbassa un intero sipario sonoro. Resta un silenzio spesso, pesante, dentro cui ancora si aggirano echi di processioni lente, canti strozzati dalla fatica, tamburi che battono come un cuore antico. Se ne va un uomo e con lui rischiano di svanire secoli di memoria orale, riti dimenticati, volti senza nome che lui aveva saputo rievocare con rispetto e verità.
De Simone è stato molte cose: musicista, regista, musicologo, antropologo, compositore, intellettuale. Ma più di tutto è stato un testimone. Un uomo che ha scelto di ascoltare le voci più deboli, quelle che la cultura ufficiale aveva ignorato o, peggio, ridicolizzato. Le voci delle lavandaie, dei pastori, dei cantastorie, dei devoti, dei contadini e delle comari, di chi piangeva nelle veglie funebri e cantava in dialetto per non impazzire. Voci che lui ha raccolto, studiato, custodito come reliquie viventi.
Con La gatta Cenerentola, De Simone non ha solo riscritto la fiaba. Ha riscritto il teatro. Ha dimostrato che Napoli e il Sud non sono un folklore da cartolina, ma un luogo colmo di stratificazioni, di dolore, di bellezza e di resistenza. Quell’opera, insieme ad altre come La cantata dei pastori o Mistero Napoletano, è diventata una crepa luminosa nel muro della cultura alta, un passaggio tra colto e popolare, tra memoria e invenzione, tra teatro e rito.
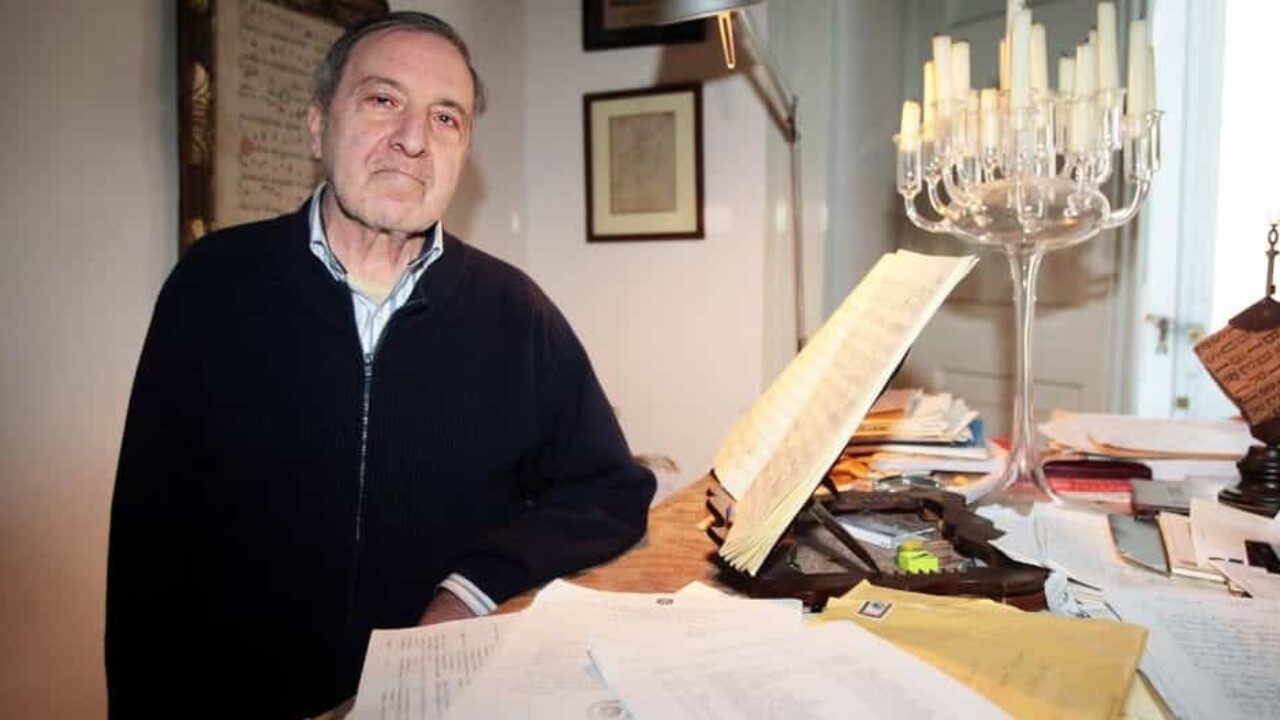
Il suo pensiero non ha mai accettato la superficialità. Per De Simone, la tradizione non era una fotografia sbiadita da appendere al muro. Era materia viva, da toccare, da interrogare. Era anche conflitto, contraddizione, oscurità. In un tempo in cui tutto tende ad appiattirsi, lui ci ha costretto a guardare l’ombra che ci portiamo dietro, i demoni delle nostre origini, il dolore sotto la festa. Ha detto, in mille modi, che non possiamo capire chi siamo senza passare da lì.
Il suo lavoro sul teatro popolare, sulla musica sacra e profana del Mezzogiorno, sulla liturgia dei sentimenti collettivi, è stato un atto d’amore e insieme un gesto politico. Perché portare sul palco il pianto rituale, la tarantella, il lamento funebre, non era folklore: era riscrivere la storia culturale d’Italia da un altro punto di vista.
Oggi che la sua voce si è spenta, ci resta la sua opera. Ma soprattutto ci resta un insegnamento forte: che la bellezza va cercata anche dove nessuno guarda più. Che il passato non è morto, se sappiamo ancora ascoltarlo. E che la cultura non è solo quello che si studia nei libri, ma anche quello che si tramanda con un sussurro, un canto storto, una festa patronale in un paese dimenticato.
Mancherà il suo sguardo lucido, ironico, appassionato. Mancherà la sua capacità di vedere l’invisibile e di renderlo scena, musica, parola. Ma forse, se abbiamo davvero imparato qualcosa da lui, ora tocca a noi portare avanti il suo lavoro. Con rispetto. Con attenzione. Con coraggio.
Arrivederci, Maestro, degnissimo figlio della nostra amata Napoli. La vostra voce non tacerà. L’ascolteremo meglio, adesso!
