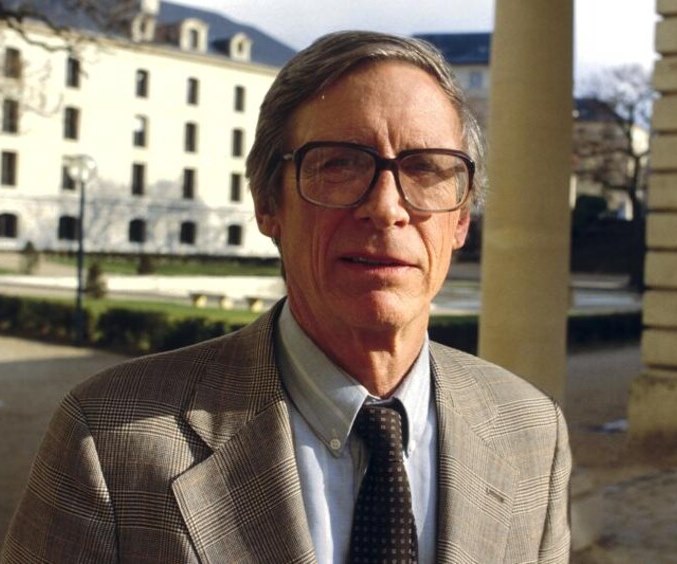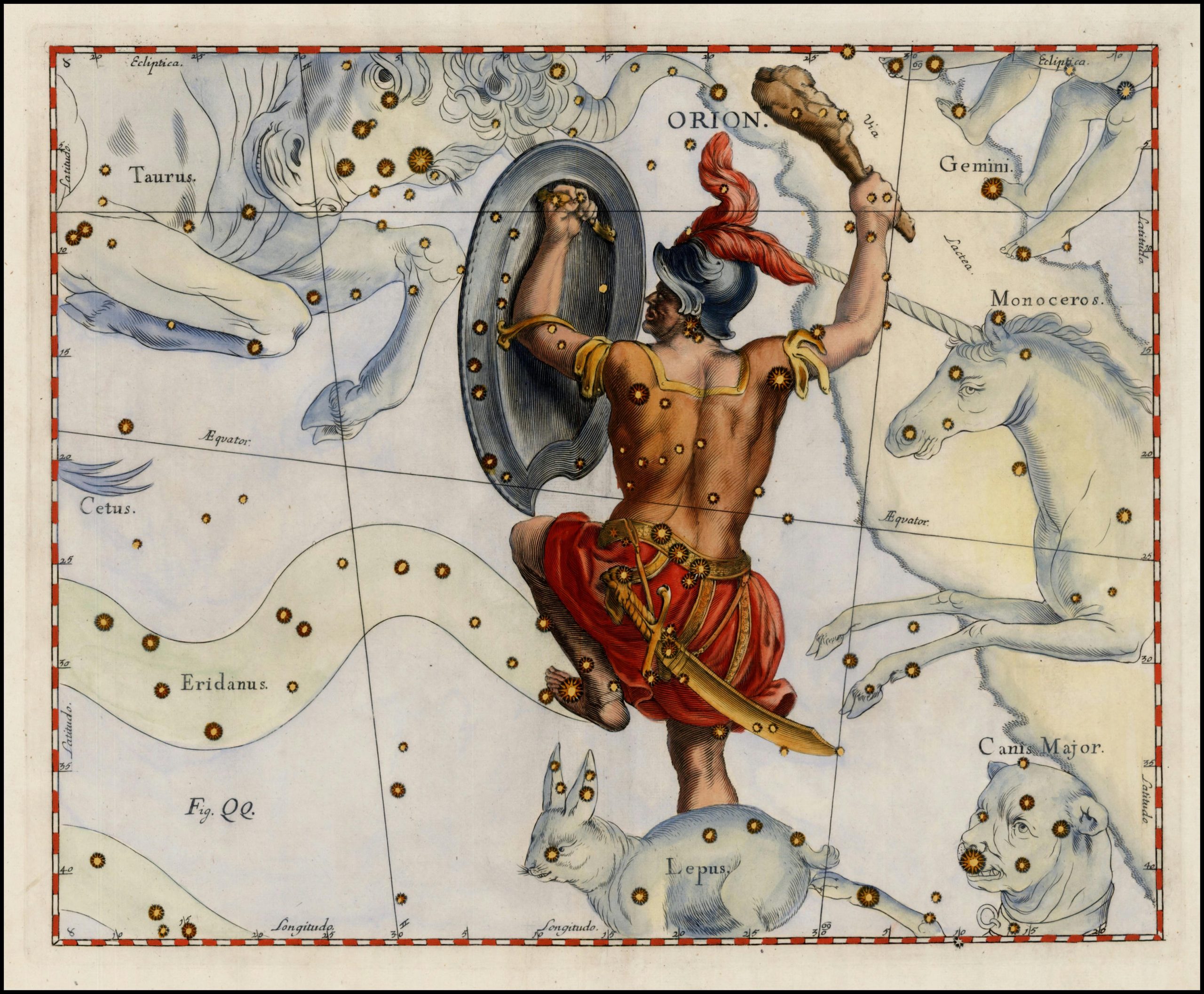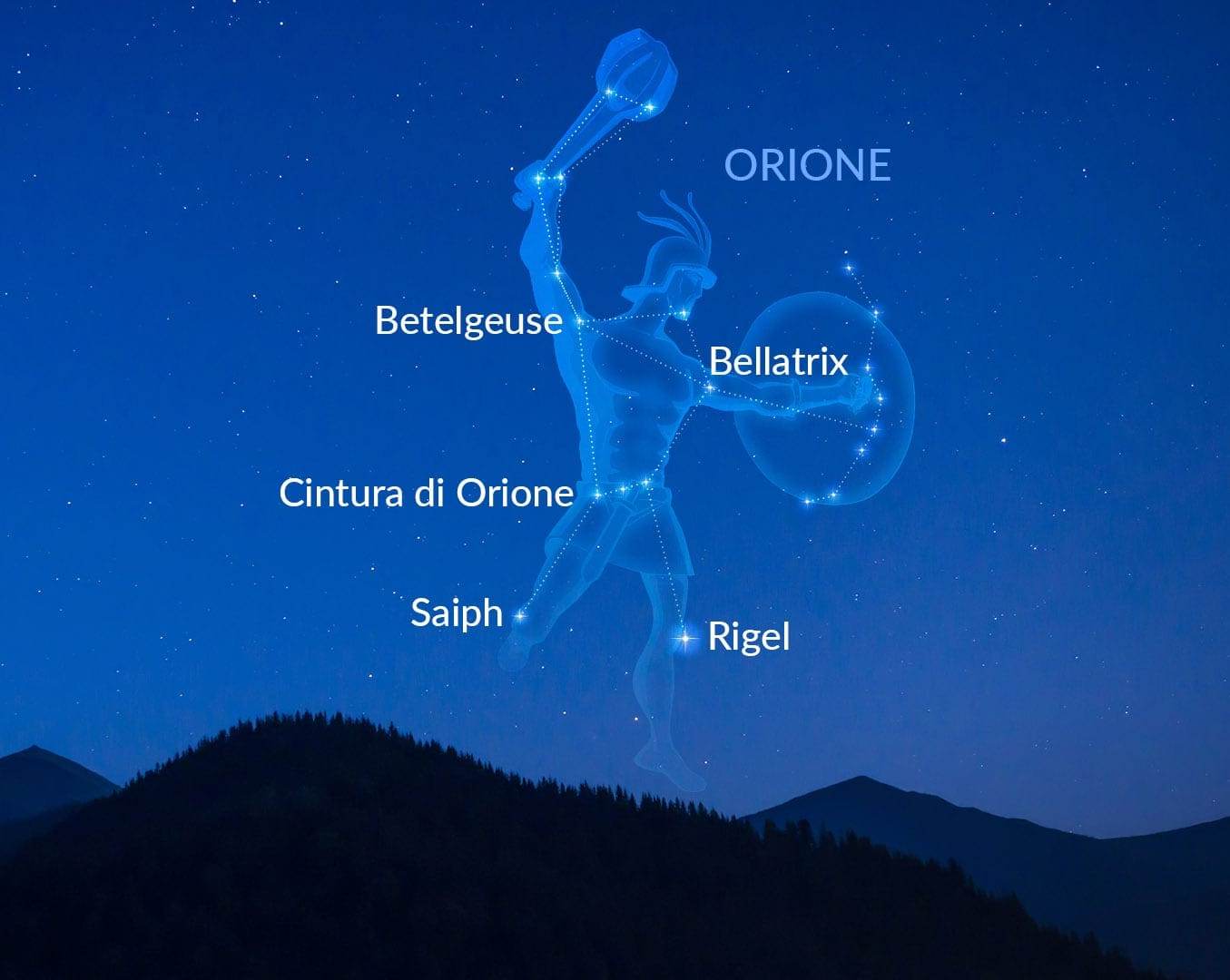Il Fons Vitae (La Fonte della Vita) è l’opera filosofica più significativa di Shelomoh ben Yehuda Ibn Gabirol (circa 1021-1058), poeta e pensatore ebreo andaluso, noto nel mondo latino come Avicebron. Composto originariamente in arabo con il titolo Yanbu’ al-Ḥayāt, il testo fu tradotto in latino nel XII secolo da Giovanni di Spagna e Domenico Gundisalvi, diventando un punto di riferimento nel pensiero filosofico medievale europeo. La sua influenza fu vasta e duratura, nonostante l’opera rimase per secoli slegata dalla tradizione ebraica, anche perché nella traduzione latina non compariva il nome dell’autore.
Il Fons Vitae non contiene citazioni bibliche né elementi specificamente ebraici. È costruito interamente come un dialogo filosofico tra maestro e discepolo, sul modello neoplatonico, con una struttura rigorosa e sistematica. Questa scelta non è casuale: Ibn Gabirol intende costruire una metafisica universale, in grado di spiegare la struttura dell’essere a prescindere dal credo religioso. Tuttavia, il suo pensiero è radicato in una visione del mondo tipicamente ebraica, dove Dio è assolutamente trascendente e la creazione non è un atto arbitrario ma ordinato secondo un principio di giustizia e armonia.
La dottrina centrale del Fons Vitae è che tutto ciò che è stato creato da Dio è composto di materia e forma, inclusi gli esseri spirituali. Questo è un punto di rottura importante rispetto alla tradizione aristotelica, secondo cui solo le cose corporee hanno materia. Avicebron estende invece la composizione materia-forma anche alle anime, agli angeli e agli intelletti separati, sostenendo che solo Dio è forma pura e assolutamente semplice.
Questa visione implica, da un lato, l’unità della creazione: tutta la realtà, dai corpi ai puri spiriti, è strutturata secondo lo stesso principio duale. Ne risulta un universo ordinato, gerarchico ma coerente, in cui ogni livello dell’essere è connesso agli altri. Dall’altro lato, essa comporta la contingenza universale: se tutto ciò che esiste, tranne Dio, ha materia, allora tutto è contingente e dipendente da Dio, che solo è necessario.

Nel Fons Vitae, Avicebron propone anche una teoria originale dell’emanazione: Dio, in quanto unità assoluta e trascendente, non agisce direttamente sulla creazione, ma tramite la sua volontà. La volontà è il primo principio emanato da Dio, e funge da intermediario tra l’Uno e il mondo molteplice.
Questo concetto di volontà come ponte tra trascendenza e immanenza ha un significato profondo: Avicebron vuole evitare l’antropomorfismo (cioè l’attribuzione a Dio di tratti umani) e allo stesso tempo spiegare come un Dio assolutamente semplice possa dare origine a una realtà molteplice e articolata. La volontà divina, pur essendo distinta da Dio, è ancora perfettamente unificata e non soggetta al cambiamento.
Il Fons Vitae è composto da cinque trattati, nei quali il maestro espone gradualmente al discepolo la struttura della realtà. L’approccio è deduttivo, astratto e sistematico: non si parte dall’esperienza sensibile, ma da princìpi metafisici che vengono via via sviluppati per spiegare il mondo creato. È un’opera complessa, che richiede familiarità con il linguaggio filosofico neoplatonico e con i concetti aristotelici, ma che offre una visione altamente coerente e profonda dell’essere.
Per lungo tempo il Fons Vitae fu letto senza sapere che l’autore fosse ebreo. Molti pensatori cristiani, in particolare i filosofi francescani come Bonaventura da Bagnoregio, ne furono profondamente ispirati, soprattutto per la sua trattazione della spiritualità della materia e della gerarchia degli esseri. Al contrario, filosofi dominicani come Tommaso d’Aquino respinsero l’idea che gli spiriti potessero essere composti di materia e forma, ritenendola incompatibile con la dottrina aristotelico-tomista.
Nel mondo ebraico, l’opera fu quasi ignorata per secoli, anche perché scritta in arabo filosofico e non in ebraico e priva di riferimenti alla Torah o al Talmud. Solo nel XIX e XX secolo, grazie agli studi di filosofi e storici come Salomon Munk, Avicebron fu pienamente riconosciuto come figura centrale del pensiero ebraico medievale.
Il Fons Vitae è un esempio emblematico del dialogo tra le tre grandi tradizioni religiose e filosofiche del Medioevo: l’ebraica, la cristiana e l’islamica. Un’opera scritta da un ebreo in arabo, tradotta in latino da un cristiano, studiata da scolastici europei e infine riscoperta come parte della tradizione ebraica: questa è la traiettoria unica del testo. Avicebron mostra come la filosofia possa essere un linguaggio universale, capace di superare confini religiosi e culturali per affrontare le grandi domande sull’essere, l’ordine e la vita.