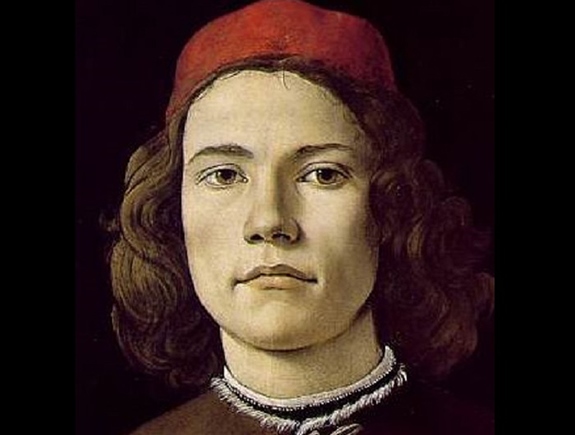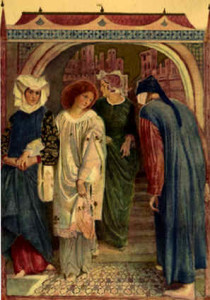di
Riccardo Piroddi
Mentre la Letteratura Italiana sonnecchiava ancora a letto, raggomitolata tra le coperte, quelle nelle altre due lingue più simili all’italiano, la francese e la spagnola, si erano già alzate, lavate, vestite e stavano facendo colazione con pane, burro, marmellata e un cappuccino bollente. I francesi e gli spagnoli, a partire dall’XI secolo, cominciarono a produrre opere letterarie di altissimo livello: in Spagna e Francia settentrionale, le cosiddette Chansons de geste (canzoni di gesta) e i romanzi cortesi; in Francia meridionale, invece, la splendida poesia, soprattutto amorosa, dei trovatori. Non che gli spagnoli e i francesi del nord fossero meno galanti con le donne, che gli piacesse di più fare la guerra o che portassero i pantaloni più lunghi dei provenzali, ma, condizioni storiche e linguistiche diverse tra queste regioni, causarono lo sviluppo di generi letterari diversi.  Nella Francia settentrionale, fin dal V secolo, c’erano stati i Franchi la cui presenza aveva prodotto effetti anche sul francese antico. A Sud, al contrario, le popolazioni locali avevano interagito poco con gli invasori e con la loro lingua. Accadde, quindi, che, col tempo, si formassero due lingue, sempre francesi, ma un po’ diverse tra loro: la lingua d’oil, o oitano, a nord, e la lingua d’oc, o occitano, a sud. Queste erano chiamate lingue del sì perché, se un cavaliere avesse chiesto a una principessa di Parigi di uscire con lui, lei gli avrebbe risposto oil, cioè sì. Se a chiederlo fosse stato un cavaliere di Montpellier alla dama vicina di castello, questa gli avrebbe risposto oc, cioè, sempre sì. Se glielo avessi chiesto io, tutt’e due mi avrebbero risposto no e basta, e, siccome non so come si dice “no e basta” in oitano e in occitano, lasciamo perdere e andiamo avanti. Per quanto riguarda la penisola Iberica, gli arabi che vi erano giunti agli inizi dell’VIII secolo, non avevano creati troppi stravolgimenti alla lingua degli abitanti di quelle terre, se non l’introduzione di parole nuove e qualche cambio di accento nella pronuncia di quelle in uso. Roba da poco, quindi.
Nella Francia settentrionale, fin dal V secolo, c’erano stati i Franchi la cui presenza aveva prodotto effetti anche sul francese antico. A Sud, al contrario, le popolazioni locali avevano interagito poco con gli invasori e con la loro lingua. Accadde, quindi, che, col tempo, si formassero due lingue, sempre francesi, ma un po’ diverse tra loro: la lingua d’oil, o oitano, a nord, e la lingua d’oc, o occitano, a sud. Queste erano chiamate lingue del sì perché, se un cavaliere avesse chiesto a una principessa di Parigi di uscire con lui, lei gli avrebbe risposto oil, cioè sì. Se a chiederlo fosse stato un cavaliere di Montpellier alla dama vicina di castello, questa gli avrebbe risposto oc, cioè, sempre sì. Se glielo avessi chiesto io, tutt’e due mi avrebbero risposto no e basta, e, siccome non so come si dice “no e basta” in oitano e in occitano, lasciamo perdere e andiamo avanti. Per quanto riguarda la penisola Iberica, gli arabi che vi erano giunti agli inizi dell’VIII secolo, non avevano creati troppi stravolgimenti alla lingua degli abitanti di quelle terre, se non l’introduzione di parole nuove e qualche cambio di accento nella pronuncia di quelle in uso. Roba da poco, quindi.
Le chansons de geste, scritte in lingua d’oil in Francia settentrionale, erano poemi epici in versi, detti canzoni perché i giullari (che non erano soltanto rozzi comici, saltimbanchi o clown, come spesso sono raffigurati, ma dei veri e propri lettori Mp3 umani, istruiti e colti), girovagando per le piazze delle città e per i castelli, narravano, cantando, spesso accompagnati da un’orchestrina, viella, lira, flauto, tamburelli e campane, storie che impressionavano e appassionavano molto nobili e popolani. Dalla viva voce di un giullare si potevano ascoltare le avventure e le gesta di re, paladini, cavalieri e uomini coraggiosissimi; pericoli, disastri, fortune e sfortune; fughe, tradimenti e morti ammazzati; teste che saltavano dai colli e fiotti di sangue che schizzavano da tutte le parti; guerre e battaglie, combattute in casa e in trasferta, contro infedeli, feudatari rivali e nemici di ogni genere. Quando, poi, quegli stessi giullari, o i monaci, oppure altri volenterosi, cominciarono a mettere quei racconti cantati per iscritto, ordinandoli per argomenti (i cosiddetti cicli carolingio e bretone o arturiano) e personaggi, furono così gentili da permetterci, ancora oggi, di poterli leggere.
La Chanson de Roland
Il poema epico più famoso di tutti, la cui materia sarebbe stata ripresa anche in Italia da Matteo Maria Boiardo e da Ludovico Ariosto, è la Chanson de Roland. Questa canzone, appartenente al ciclo carolingio, fu composta, intorno al 1100, da un certo Turoldo. Conosciamo il suo nome perché, all’ultima pagina, lui stesso mise la firma, concludendo così: “La gesta scritta qui da Turoldo ha fine”. L’autore prese spunto da un fatto realmente accaduto: la battaglia di Roncisvalle, combattuta il 15 agosto del 778.  La retroguardia dell’esercito di Carlo Magno, comandata dal paladino Rolando, fu attaccata e annientata dai baschi, alleati dei saraceni. Turoldo amplia questo episodio, raccontando una lunghissima storia. Re Carlo combatteva vittoriosamente i mori in Spagna. Soltanto la città di Saragozza gli resisteva e non gli si voleva arrendere in nessun modo. Il re saraceno Marsilio mandò i suoi ambasciatori da Carlo, giurandogli di volersi convertire al Cristianesimo e di diventare suo vassallo. Era solo un inganno. Rolando, più furbo di tutti, capì il trucco e suggerì al suo sovrano di ignorare le proposte del nemico, continuando, piuttosto, a combatterlo, fino alla presa definitiva di Saragozza. L’infame conte Gano, tanto invidioso di Rolando da non vedere l’ora di farlo fuori, si oppose e, con lui, la maggior parte del Consiglio di guerra. Su proposta di Rolando, quindi, proprio Gano fu inviato al campo dei mori per trattare, con il loro re, le pesantissime condizioni di resa imposte da Carlo. Mentre vi si dirigeva, pensò di tradire il suo re e, in un colpo solo, di eliminare anche Rolando. Il perfido conte propose a Marsilio di far finta di accettare quanto ordinato dal re cristiano. Così fu fatto. Carlo Magno e il suo esercito abbandonarono la città, lasciandosi alle spalle la sola retroguardia, capitanata da Rolando, con i Dodici Pari e 20.000 soldati. Quando il grosso delle truppe aveva già oltrepassato la gola di Roncisvalle, Marsilio tese l’agguato al valoroso paladino e ai suoi uomini. Rolando, nonostante la malaparata, si rifiutò di suonare l’olifante, il corno il cui suono avrebbe richiamato Carlo e il resto dell’esercito. Fece, pertanto, la fine del topo in trappola, morendo con le mani giunte sul petto, come un buon cristiano. Il re franco, comunque, tornò indietro in tempo per sbaragliare i mori, disperderli e inseguirli fino a che tutti si gettassero nel fiume Ebro, annegando. Tornato ad Aquisgrana, processò il lurido Gano, ordinando che fosse legato a quattro cavalli, due alle gambe e due alle braccia. Il traditore fu squartato. Rolando era stato vendicato. Molto tempo dopo, quando Carlo aveva più di duecento anni, una notte gli apparve in sogno l’Arcangelo Gabriele.
La retroguardia dell’esercito di Carlo Magno, comandata dal paladino Rolando, fu attaccata e annientata dai baschi, alleati dei saraceni. Turoldo amplia questo episodio, raccontando una lunghissima storia. Re Carlo combatteva vittoriosamente i mori in Spagna. Soltanto la città di Saragozza gli resisteva e non gli si voleva arrendere in nessun modo. Il re saraceno Marsilio mandò i suoi ambasciatori da Carlo, giurandogli di volersi convertire al Cristianesimo e di diventare suo vassallo. Era solo un inganno. Rolando, più furbo di tutti, capì il trucco e suggerì al suo sovrano di ignorare le proposte del nemico, continuando, piuttosto, a combatterlo, fino alla presa definitiva di Saragozza. L’infame conte Gano, tanto invidioso di Rolando da non vedere l’ora di farlo fuori, si oppose e, con lui, la maggior parte del Consiglio di guerra. Su proposta di Rolando, quindi, proprio Gano fu inviato al campo dei mori per trattare, con il loro re, le pesantissime condizioni di resa imposte da Carlo. Mentre vi si dirigeva, pensò di tradire il suo re e, in un colpo solo, di eliminare anche Rolando. Il perfido conte propose a Marsilio di far finta di accettare quanto ordinato dal re cristiano. Così fu fatto. Carlo Magno e il suo esercito abbandonarono la città, lasciandosi alle spalle la sola retroguardia, capitanata da Rolando, con i Dodici Pari e 20.000 soldati. Quando il grosso delle truppe aveva già oltrepassato la gola di Roncisvalle, Marsilio tese l’agguato al valoroso paladino e ai suoi uomini. Rolando, nonostante la malaparata, si rifiutò di suonare l’olifante, il corno il cui suono avrebbe richiamato Carlo e il resto dell’esercito. Fece, pertanto, la fine del topo in trappola, morendo con le mani giunte sul petto, come un buon cristiano. Il re franco, comunque, tornò indietro in tempo per sbaragliare i mori, disperderli e inseguirli fino a che tutti si gettassero nel fiume Ebro, annegando. Tornato ad Aquisgrana, processò il lurido Gano, ordinando che fosse legato a quattro cavalli, due alle gambe e due alle braccia. Il traditore fu squartato. Rolando era stato vendicato. Molto tempo dopo, quando Carlo aveva più di duecento anni, una notte gli apparve in sogno l’Arcangelo Gabriele.  Questi gli annunziò l’immediata partenza per Infa, dove avrebbe dovuto aiutare il re Viviano a combattere altri mori. Così finì la storia. Turoldo, come è chiaro, aggiunse molti elementi fantasiosi alla realtà dei fatti. Questo perché egli doveva, non soltanto intrattenere chi lo ascoltasse, ma, soprattutto, mostrare loro esempi retti da seguire. Gli eroi di queste canzoni di gesta erano un po’ come i personaggi della televisione di oggi: tutti volevano e, soprattutto, dovevano essere come loro. Le canzoni di gesta erano caratterizzate dalla presenza e dalla messa in onda di precisi valori: la lealtà verso il sovrano, la fede in Cristo, il senso dell’onore e l’eroismo in battaglia. Tutto racchiuso in un ineluttabile destino, scritto da sempre, che non lasciava ai protagonisti alcuna possibilità di azione personale: o erano e agivano in quel modo, oppure, avrebbero dovuto fare i bagagli e trasferirsi in qualche altro tipo di opera. O mangi ‘sta minestra, o ti butti dalla finestra, in sostanza! In un’epoca dominata esclusivamente dal Cristianesimo e dalla sua morale, questi erano i messaggi pubblicitari che le emittenti cartacee diffondevano via manoscritto: i re dovevano sembrare più o meno come Gesù; i paladini, sempre dodici, gli apostoli; non mancava mai il Giuda di turno; i morti in battaglia erano tutti martiri e quelli più importanti, santi; ogni combattimento diventava una vera e propria guerra santa; pentimenti finali e conversioni al Cristianesimo, l’epilogo necessario. Era come leggere il Vangelo e gli Atti degli Apostoli con i nomi dei protagonisti sostituiti. Altri poemi del ciclo carolingio sono la Chanson de Guillaume, dedicata alla saga di Guglielmo d’Orange e della sua famiglia, a salire e a scendere, cioè, prima e dopo di lui; il Renaut de Montauban; il Girart de Roussillon e il Pelérinage Charlemagne. Un posto particolare occupano le canzoni di Crociata, nelle si esaltavano le gesta dei cavalieri occidentali nelle guerre per liberare il Santo Sepolcro, a Gerusalemme: la Chanson d’Antioche e Le Chevalier au cygne (il Cavaliere del cigno), quel Goffredo di Buglione, comandante dell’esercito cristiano nella Prima Crociata. Di tutte queste, però, non vi racconto le trame altrimenti, se state leggendo di pomeriggio, fate notte, se, invece, è già sera, fate mattina.
Questi gli annunziò l’immediata partenza per Infa, dove avrebbe dovuto aiutare il re Viviano a combattere altri mori. Così finì la storia. Turoldo, come è chiaro, aggiunse molti elementi fantasiosi alla realtà dei fatti. Questo perché egli doveva, non soltanto intrattenere chi lo ascoltasse, ma, soprattutto, mostrare loro esempi retti da seguire. Gli eroi di queste canzoni di gesta erano un po’ come i personaggi della televisione di oggi: tutti volevano e, soprattutto, dovevano essere come loro. Le canzoni di gesta erano caratterizzate dalla presenza e dalla messa in onda di precisi valori: la lealtà verso il sovrano, la fede in Cristo, il senso dell’onore e l’eroismo in battaglia. Tutto racchiuso in un ineluttabile destino, scritto da sempre, che non lasciava ai protagonisti alcuna possibilità di azione personale: o erano e agivano in quel modo, oppure, avrebbero dovuto fare i bagagli e trasferirsi in qualche altro tipo di opera. O mangi ‘sta minestra, o ti butti dalla finestra, in sostanza! In un’epoca dominata esclusivamente dal Cristianesimo e dalla sua morale, questi erano i messaggi pubblicitari che le emittenti cartacee diffondevano via manoscritto: i re dovevano sembrare più o meno come Gesù; i paladini, sempre dodici, gli apostoli; non mancava mai il Giuda di turno; i morti in battaglia erano tutti martiri e quelli più importanti, santi; ogni combattimento diventava una vera e propria guerra santa; pentimenti finali e conversioni al Cristianesimo, l’epilogo necessario. Era come leggere il Vangelo e gli Atti degli Apostoli con i nomi dei protagonisti sostituiti. Altri poemi del ciclo carolingio sono la Chanson de Guillaume, dedicata alla saga di Guglielmo d’Orange e della sua famiglia, a salire e a scendere, cioè, prima e dopo di lui; il Renaut de Montauban; il Girart de Roussillon e il Pelérinage Charlemagne. Un posto particolare occupano le canzoni di Crociata, nelle si esaltavano le gesta dei cavalieri occidentali nelle guerre per liberare il Santo Sepolcro, a Gerusalemme: la Chanson d’Antioche e Le Chevalier au cygne (il Cavaliere del cigno), quel Goffredo di Buglione, comandante dell’esercito cristiano nella Prima Crociata. Di tutte queste, però, non vi racconto le trame altrimenti, se state leggendo di pomeriggio, fate notte, se, invece, è già sera, fate mattina.
Il Cantar de mio Cid
Giusto per rimanere nell’epica, c’è un altro poema, non in Francia, ma in Spagna, di cui vi voglio parlare: il Cantar de mio Cid. Vi sono narrate le imprese eroiche di Roderigo Diaz de Bivar, altrimenti detto El Cid Campeador, vissuto tra il 1043 e il 1099. La storia, o meglio, la canzone, prende avvio quando Roderigo fu accusato di aver sgraffignato una parte dei tributi che il re dei mori di Andalusia doveva ad Alfonso VI di León. Per questo, fu mandato in esilio. Lasciò la moglie Jimena e le figlie nel monastero di Cardeña, per paura che qualcuno potesse insidiarle, e, alla testa di molti altri cavalieri, si mise a far la guerra ai mori. Conquistò Valencia e cacciò il re di Siviglia, ottenendo, alla fine, il perdono del re. Per dimostrargli ulteriore gratitudine, il sovrano benedisse il matrimonio delle sue due figlie, Elvira e Sol, con i conti di Carrión. Questi due perdigiorno, però, ogniqualvolta c’era da andare a combattere se la prendevano con le mogli, frustandole e, poi, squagliandosela. Il Cid, stanco delle angherie subite dalle figlie, chiese giustizia a re Alfonso che inviò i suoi soldati ad ammazzare quei due mariti violenti. Le giovani si risposarono, una col figlio del re di Navarra, l’altra con quello del re d’Aragona, Tutti furono invitati ai due matrimoni e il povero Cid Campeador, eroe di tante battaglie, dovette chiedere un prestito in banca per pagare le ingentissime spese, perché, allora, le spese del banchetto nuziale e dei musici erano a carico del padre della sposa. Anche questo poema, tra i primissimi documenti della letteratura spagnola, celebrava quei valori comuni a tutta l’epica: la fede in Dio, la devozione al proprio re, la lotta agli infedeli, l’onore e l’eroismo. Due piccoli tip linguistici sull’appellativo di Roderigo Diaz: Cid deriva dalla parola araba sayyd, che vuol dire signore; Campeador, invece, è di provenienza latina, da campi doctor, maestro, o anche campione, sul campo di battaglia. Esempi di parole arabe e latine entrate in uso, ovviamente adattandosi, nella lingua spagnola, così come, casi lessicologici analoghi, sono presenti in tutte le lingue dei territori dominati, fino a qualche secolo prima, dall’aquila di Roma.
Questi due perdigiorno, però, ogniqualvolta c’era da andare a combattere se la prendevano con le mogli, frustandole e, poi, squagliandosela. Il Cid, stanco delle angherie subite dalle figlie, chiese giustizia a re Alfonso che inviò i suoi soldati ad ammazzare quei due mariti violenti. Le giovani si risposarono, una col figlio del re di Navarra, l’altra con quello del re d’Aragona, Tutti furono invitati ai due matrimoni e il povero Cid Campeador, eroe di tante battaglie, dovette chiedere un prestito in banca per pagare le ingentissime spese, perché, allora, le spese del banchetto nuziale e dei musici erano a carico del padre della sposa. Anche questo poema, tra i primissimi documenti della letteratura spagnola, celebrava quei valori comuni a tutta l’epica: la fede in Dio, la devozione al proprio re, la lotta agli infedeli, l’onore e l’eroismo. Due piccoli tip linguistici sull’appellativo di Roderigo Diaz: Cid deriva dalla parola araba sayyd, che vuol dire signore; Campeador, invece, è di provenienza latina, da campi doctor, maestro, o anche campione, sul campo di battaglia. Esempi di parole arabe e latine entrate in uso, ovviamente adattandosi, nella lingua spagnola, così come, casi lessicologici analoghi, sono presenti in tutte le lingue dei territori dominati, fino a qualche secolo prima, dall’aquila di Roma.

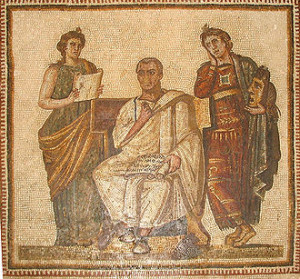
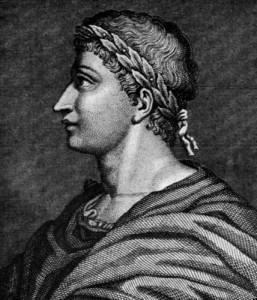
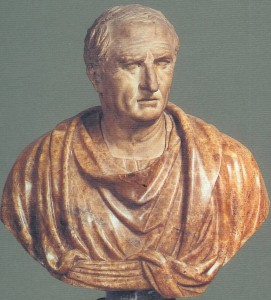
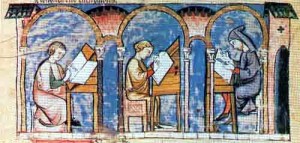
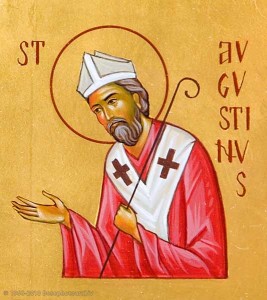
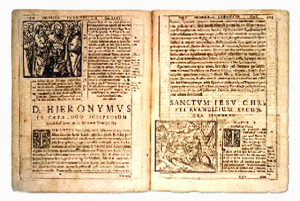
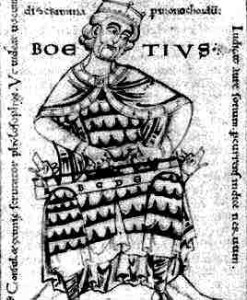


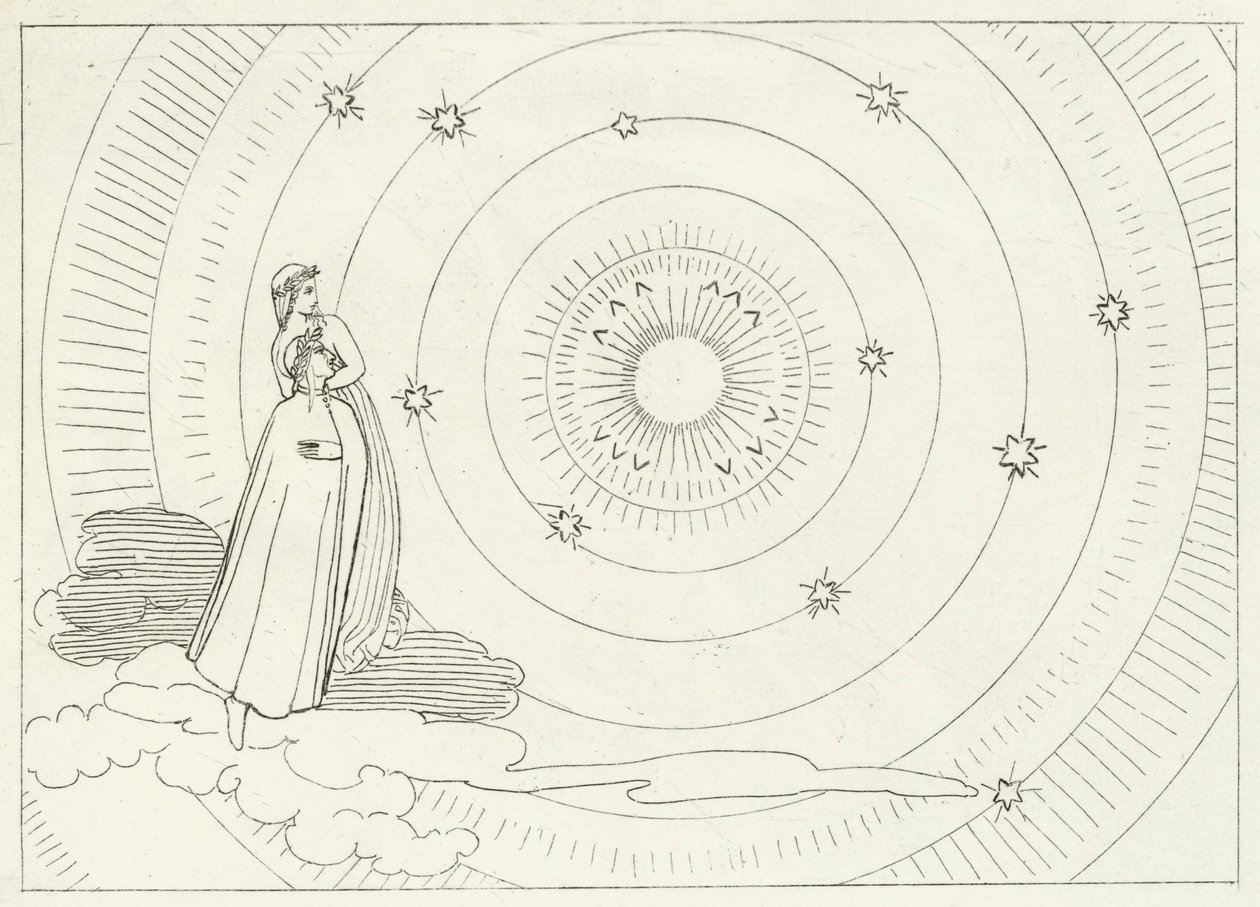


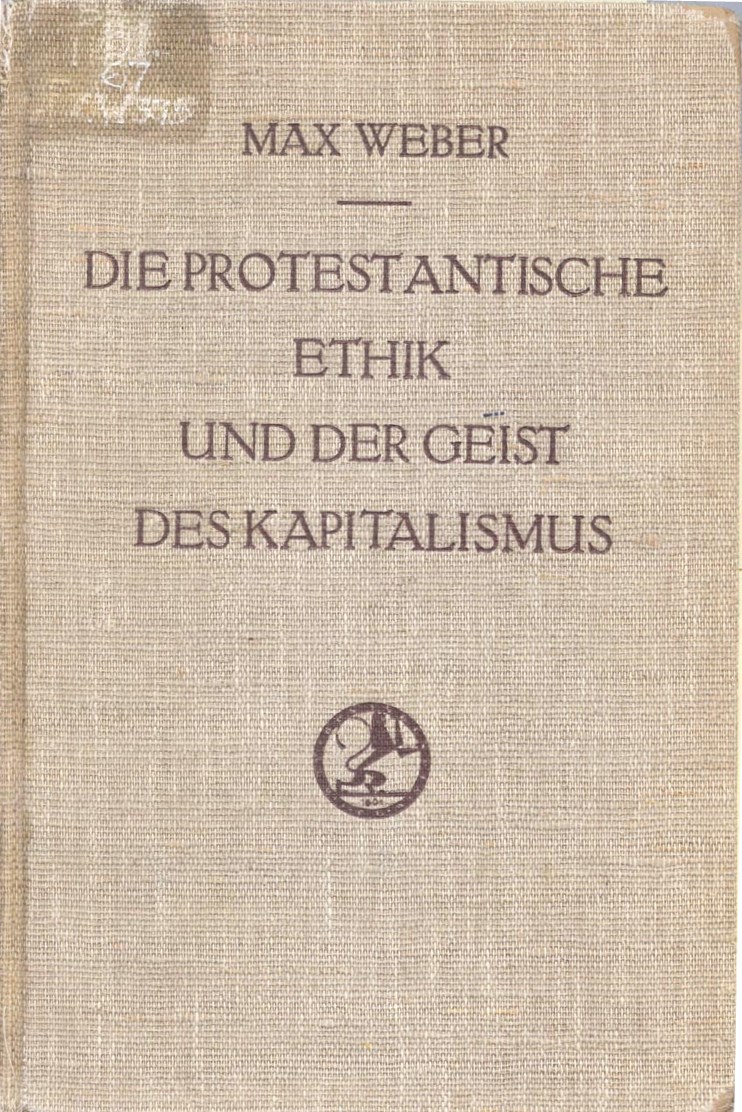 L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber, pubblicata nel 1905, è un’opera fondamentale che sonda l’influenza della religione sullo sviluppo economico e culturale dell’Occidente. Attraverso un’analisi meticolosa e interdisciplinare, l’Autore intreccia filosofia, storia, letteratura e religione, per rivelare come l’etica protestante abbia contribuito a modellare il moderno capitalismo.
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber, pubblicata nel 1905, è un’opera fondamentale che sonda l’influenza della religione sullo sviluppo economico e culturale dell’Occidente. Attraverso un’analisi meticolosa e interdisciplinare, l’Autore intreccia filosofia, storia, letteratura e religione, per rivelare come l’etica protestante abbia contribuito a modellare il moderno capitalismo.


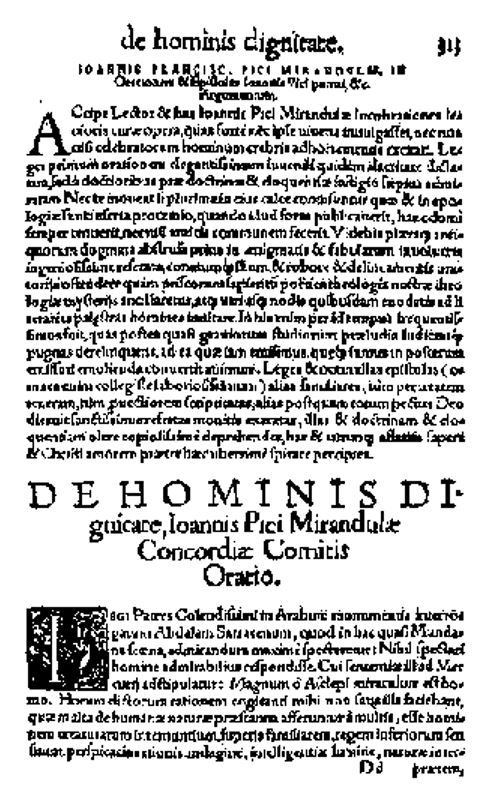 Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.
Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.