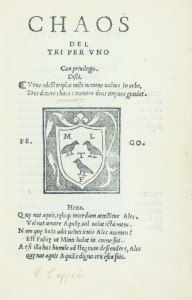Giorgio Vasari
Il Rinascimento ha mostrato i suoi frutti soprattutto nelle arti figurative. Un’opera d’arte (di ogni epoca!) parla di sé soltanto ad ammirarla, ma spesso racconta poco della vita del suo autore. Ci fu un uomo, pittore, architetto e letterato, che pensò bene di raccogliere le biografie e le tecniche artistiche di tutti quei personaggi i quali, lungo il Rinascimento, regalarono i loro capolavori all’umanità. Questi fu Giorgio Vasari. Nato ad Arezzo nel 1511, giovanissimo, fu a bottega da Michelangelo, da Andrea del Baccio e da Baccio Bandinelli. Fu l’artista ufficiale di Cosimo I a Firenze, per il quale progettò gli Uffizi e affrescò la volta della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il titolo della sua raccolta di biografie illustri è: “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri“, cioè suoi, cioè fino a Michelangelo, in cui colleziona 195 biografie, concludendo con la propria. Ma non solo. Racconti e curiosità arricchiscono la narrazione dell’esistenza di questi uomini eccezionali. Anche se molte date non risultano essere precise e tanti aneddoti sono stati inventati da lui stesso, come, ad esempio, quella secondo cui Cimabue provasse ripetutamente a scacciare la mosca che Giotto aveva disegnato su un suo quadro, l’opera ha avuto e ha, ancora oggi, valore di guida fondamentale per la storia dell’arte italiana dal Trecento al Cinquecento. Da toscano, Vasari pone in ottima luce gli artisti della sua regione ed è sempre parziale anche quando, nella seconda edizione, inserisce maestri di altre parti d’Italia.
loro capolavori all’umanità. Questi fu Giorgio Vasari. Nato ad Arezzo nel 1511, giovanissimo, fu a bottega da Michelangelo, da Andrea del Baccio e da Baccio Bandinelli. Fu l’artista ufficiale di Cosimo I a Firenze, per il quale progettò gli Uffizi e affrescò la volta della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il titolo della sua raccolta di biografie illustri è: “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri“, cioè suoi, cioè fino a Michelangelo, in cui colleziona 195 biografie, concludendo con la propria. Ma non solo. Racconti e curiosità arricchiscono la narrazione dell’esistenza di questi uomini eccezionali. Anche se molte date non risultano essere precise e tanti aneddoti sono stati inventati da lui stesso, come, ad esempio, quella secondo cui Cimabue provasse ripetutamente a scacciare la mosca che Giotto aveva disegnato su un suo quadro, l’opera ha avuto e ha, ancora oggi, valore di guida fondamentale per la storia dell’arte italiana dal Trecento al Cinquecento. Da toscano, Vasari pone in ottima luce gli artisti della sua regione ed è sempre parziale anche quando, nella seconda edizione, inserisce maestri di altre parti d’Italia.
Benvenuto Cellini
Chi è stato a letto con una donna o con un uomo dello spettacolo, scrive la propria biografia; chi è uscito da un centro di recupero per tossicodipendenti e fa parte sempre dello spettacolo,  scrive la propria biografia; chi ha commesso uno o più omicidi, scrive la propria biografia o, almeno, se la fa scrivere; chi ha vinto una medaglia, scrive la propria biografia; chi ne ha combinate di grosse, veramente grosse, scrive la propria biografia… Chiunque potrebbe scrivere la propria biografia, raccontare di quando è nato, di quanto i suoi genitori gli abbiano voluto bene, di come si sia divertito non sempre in modo troppo sano, eccetera, eccetera. Non sarebbe il primo e nemmeno l’ultimo. C’è comunque stato qualcuno, il primo, appunto, che scrisse la storia della propria vita: fu un artista, Benvenuto Cellini. Quando nacque, il 3 Novembre 1500, a Firenze, suo padre Giovanni, fabbricatore di strumenti musicali, aspettava una femmina, ma non appena lo vide, strillò: “Benvenuto!” e quello fu il suo nome. Fu a bottega da vari maestri a Firenze, Bologna, Siena e Pisa. Ad averlo conosciuto, si sarebbe capito immediatamente che era una testa calda, anzi caldissima. Risse, botte, coltellate, schioppettate, con lui erano cose comuni. Pare che, quando partecipò alla difesa di Castel Sant’Angelo, durante il sacco di Roma del 1527, con le palle del suo di archibugio uccidesse il comandante dell’esercito imperiale, Carlo di Borbone, e ferisse, poi, Filiberto di Chalons, principe d’Orange, che aveva preso il suo posto. Era uno che sapeva bene come usare le armi da fuoco. Per quel che riguarda la sua carriera d’artista, fuse il famoso Perseo,
scrive la propria biografia; chi ha commesso uno o più omicidi, scrive la propria biografia o, almeno, se la fa scrivere; chi ha vinto una medaglia, scrive la propria biografia; chi ne ha combinate di grosse, veramente grosse, scrive la propria biografia… Chiunque potrebbe scrivere la propria biografia, raccontare di quando è nato, di quanto i suoi genitori gli abbiano voluto bene, di come si sia divertito non sempre in modo troppo sano, eccetera, eccetera. Non sarebbe il primo e nemmeno l’ultimo. C’è comunque stato qualcuno, il primo, appunto, che scrisse la storia della propria vita: fu un artista, Benvenuto Cellini. Quando nacque, il 3 Novembre 1500, a Firenze, suo padre Giovanni, fabbricatore di strumenti musicali, aspettava una femmina, ma non appena lo vide, strillò: “Benvenuto!” e quello fu il suo nome. Fu a bottega da vari maestri a Firenze, Bologna, Siena e Pisa. Ad averlo conosciuto, si sarebbe capito immediatamente che era una testa calda, anzi caldissima. Risse, botte, coltellate, schioppettate, con lui erano cose comuni. Pare che, quando partecipò alla difesa di Castel Sant’Angelo, durante il sacco di Roma del 1527, con le palle del suo di archibugio uccidesse il comandante dell’esercito imperiale, Carlo di Borbone, e ferisse, poi, Filiberto di Chalons, principe d’Orange, che aveva preso il suo posto. Era uno che sapeva bene come usare le armi da fuoco. Per quel che riguarda la sua carriera d’artista, fuse il famoso Perseo,  una statua di bronzo alta 5 metri e 20 centimetri, cesellò l’altrettanto celebre Saliera per Francesco I di Francia (immagine a destra) e creò tante altre belle opere d’arte. Giunto a 58 anni (per la vita che condusse un incredibile traguardo!), decise di mettere per iscritto la parabola della sua esistenza: “La vita di Benvenuto Cellini fiorentino, scritta (per lui medesimo) in Firenze“. L’Autore, sebbene fosse un artista, racconta se stesso, non le sue opere d’arte. Per la prima volta, egli mette in scena la sua vita, nella sua crudezza, nelle sue avventure, senza metafore e senza voler insegnare nulla. Questa è stata la novità. Momenti belli e momenti brutti, brave persone e farabutti, sangue, donne e cortigiani, amore e odio, fame, sete, ubriachezza e sazietà, puttane e ruffiani, invidia e generosità, fughe, prigioni e colpi a serramanico, ce n’è per tutti i gusti. La sua storia, insieme all’indubbio valore letterario, è avvincente e incredibile. Sono certo che essa piacerebbe non solo ai “tecnici” della letteratura, ma anche a lettori abituati a sfogliare libri impegnativi e istruttivi (sicuro!) come “Cigno” (Naomi Campbell, “Cigno“, Mondadori, 1995), “Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda” (Paolo Villaggio, “Vita morte e miracoli di un pezzo di merda“, Mondadori, 2002), “Costantino Desnudo” (Alfonso Signorini, “Costantino Denudo“, Maestrale Company, 2004), “Io e me stessa” (Lory del Santo, “Io e me stessa“, Sperling&Kupfer, 2006) e via dicendo.
una statua di bronzo alta 5 metri e 20 centimetri, cesellò l’altrettanto celebre Saliera per Francesco I di Francia (immagine a destra) e creò tante altre belle opere d’arte. Giunto a 58 anni (per la vita che condusse un incredibile traguardo!), decise di mettere per iscritto la parabola della sua esistenza: “La vita di Benvenuto Cellini fiorentino, scritta (per lui medesimo) in Firenze“. L’Autore, sebbene fosse un artista, racconta se stesso, non le sue opere d’arte. Per la prima volta, egli mette in scena la sua vita, nella sua crudezza, nelle sue avventure, senza metafore e senza voler insegnare nulla. Questa è stata la novità. Momenti belli e momenti brutti, brave persone e farabutti, sangue, donne e cortigiani, amore e odio, fame, sete, ubriachezza e sazietà, puttane e ruffiani, invidia e generosità, fughe, prigioni e colpi a serramanico, ce n’è per tutti i gusti. La sua storia, insieme all’indubbio valore letterario, è avvincente e incredibile. Sono certo che essa piacerebbe non solo ai “tecnici” della letteratura, ma anche a lettori abituati a sfogliare libri impegnativi e istruttivi (sicuro!) come “Cigno” (Naomi Campbell, “Cigno“, Mondadori, 1995), “Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda” (Paolo Villaggio, “Vita morte e miracoli di un pezzo di merda“, Mondadori, 2002), “Costantino Desnudo” (Alfonso Signorini, “Costantino Denudo“, Maestrale Company, 2004), “Io e me stessa” (Lory del Santo, “Io e me stessa“, Sperling&Kupfer, 2006) e via dicendo.