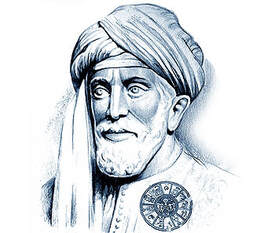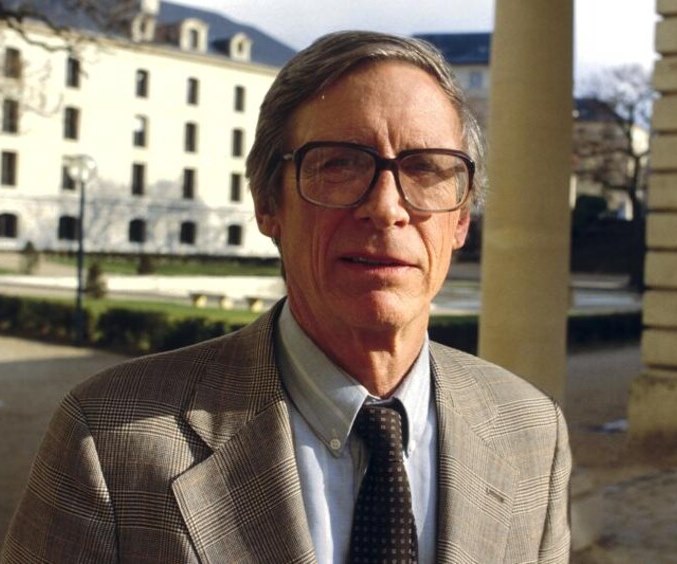Il concetto di eggregoro appartiene alla tradizione esoterica occidentale e si riferisce a un’entità psichica o spirituale collettiva generata dalla somma delle intenzioni, emozioni e pensieri di un gruppo umano coeso intorno a un obiettivo, un simbolo o una credenza comune. Si tratta di un’idea che, pur nascendo in ambito occultista, presenta implicazioni rilevanti anche nel campo della psicologia collettiva, della sociologia e della filosofia della mente.
L’origine etimologica della parola risale al greco antico egrégoroi (ἐγρήγοροι), utilizzato nel Libro di Enoch per indicare “coloro che vegliano”, ovvero esseri spirituali caduti, spesso interpretati come angeli ribelli. Questo riferimento biblico-apocrifo, ripreso successivamente da testi esoterici tardo-ottocenteschi, viene rielaborato da occultisti come Éliphas Lévi, il quale, nei suoi scritti, in particolare Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854-1856), ipotizza l’esistenza di entità astrali influenzate dalla volontà umana, suggerendo che gruppi di persone possano, attraverso il rituale e la concentrazione mentale, “creare” vere e proprie forze intelligenti.
Il concetto assume una forma più strutturata nell’ambito delle scuole esoteriche moderne, come l’Hermetic Order of the Golden Dawn e, più tardi, nella Societas Rosicruciana in Anglia. Arthur Edward Waite, in alcune sue opere sulla magia cerimoniale, accenna alla possibilità che un gruppo coeso e disciplinato possa generare una presenza autonoma, dotata di una sorta di identità propria. Questo pensiero verrà poi approfondito nel XX secolo da autori come Dion Fortune, che nel suo Psychic Self-Defense (1930) descrive gli eggregori come forme-pensiero collettive dotate di potere reale nel mondo psichico e in grado di esercitare influenza sui singoli membri del gruppo.
Negli anni successivi, l’idea di eggregoro trova una nuova sistematizzazione nell’opera di Valentin Tomberg, autore dei Meditations on the Tarot (pubblicato postumo nel 1980), in cui il concetto viene associato alla realtà degli archetipi collettivi e delle strutture immaginative che plasmano l’esperienza spirituale dell’essere umano.

Sebbene il termine non faccia parte del vocabolario scientifico, il concetto di eggregoro può essere messo in relazione con alcune teorie psicologiche, in particolare con la psicologia del profondo. Carl Gustav Jung, pur non utilizzando questa parola, descrive nel suo lavoro l’esistenza di archetipi condivisi che abitano l’inconscio collettivo e influenzano profondamente le strutture simboliche e i comportamenti individuali. Gli archetipi, come forze impersonali e transpersonali, possono essere attivati da energie collettive e assumere un ruolo dominante nei contesti culturali o nei gruppi sociali.
In questo senso, un eggregoro può essere visto come un archetipo attualizzato attraverso la partecipazione emotiva e simbolica del gruppo, che ne rinforza la coerenza interna e lo “incarna” in forme riconoscibili, talvolta mitizzate. La dinamica del transfert collettivo, concettualizzata anche in ambito psicoanalitico, descrive in termini clinici come il singolo individuo possa perdere il senso critico quando immerso in una psiche di gruppo altamente suggestiva.
Nella cultura contemporanea, l’idea di eggregoro si manifesta sotto forma di identità collettive che acquisiscono vita propria. Ad esempio, la cultura di marca (brand culture), come evidenziato da Naomi Klein in No Logo (1999), mostra come alcuni marchi diventino “organismi viventi” capaci di aggregare comunità di consumatori affezionati, alimentare immaginari condivisi e influenzare scelte comportamentali e valoriali. Il marchio non è solo un simbolo commerciale, ma un catalizzatore di significati, simile a un eggregoro: è sostenuto da narrazioni, rituali, fedeltà e perfino forme di identificazione personale.
Anche nei fenomeni politici e ideologici troviamo dinamiche simili. La propaganda, i rituali di appartenenza e le rappresentazioni simboliche condivise (bandiere, slogan, inni) rafforzano l’eggregoro ideologico di una nazione, di un partito o di un movimento. Lo stesso accade nelle religioni istituzionalizzate, dove divinità, santi o figure carismatiche vengono alimentate da millenni di devozione collettiva, diventando entità psichiche stabili nella memoria e nella pratica dei fedeli.
Nel contesto digitale, il concetto di eggregoro si rivela particolarmente attuale. Le comunità online, i fandom, le subculture nate sui social media producono continuamente nuove entità psichiche collettive, alimentate da flussi costanti di attenzione, affetto, indignazione o partecipazione. La viralità stessa può essere interpretata come un meccanismo di “nutrimento” energetico per queste forme simboliche, che acquistano rilevanza, potere e resistenza grazie alla massa critica di utenti coinvolti.
Secondo alcuni esoteristi contemporanei, tra cui Mark Stavish nel suo libro Egregores: The Occult Entities That Watch Over Human Destiny (2018), un eggregoro può diventare tanto potente da acquisire un’autonomia relativa, condizionando le decisioni dei singoli anche al di fuori della loro volontà conscia. Questo lo rende uno strumento potente, ma anche potenzialmente pericoloso. Un eggregoro positivo può sostenere un movimento evolutivo, spirituale o sociale; uno negativo può degenerare in fanatismo, controllo psichico e regressione collettiva.
L’idea che una forma-pensiero collettiva possa “sopravvivere” a chi l’ha creata è centrale nella teoria esoterica. Alcuni eggregori, una volta generati, tendono a mantenere la loro coerenza e persistenza attraverso nuove generazioni di aderenti, mantenendo il nucleo simbolico e adattandosi ai mutamenti storici. Si parla in questo caso di eggregori longevi, come quelli associati alle grandi religioni, agli ordini iniziatici o a istituzioni culturali millenarie.
L’eggregoro, quindi, pur rimanendo un concetto non scientifico in senso stretto, rappresenta una metafora potente per interpretare la dinamica psichica e simbolica dei gruppi umani. Che lo si consideri un’entità spirituale autonoma o una rappresentazione delle forze collettive dell’inconscio, esso permette di indagare come le idee si trasformino in strutture vive, capaci di influenzare individui, società e culture. Comprendere gli eggregori significa riconoscere che il pensiero collettivo non è una semplice somma di pensieri individuali, ma una forza emergente, complessa, talvolta creativa, talvolta distruttiva. In un’epoca in cui la partecipazione di massa è mediata da tecnologie istantanee e dove le identità si formano spesso all’interno di spazi virtuali, la consapevolezza della natura e del potere degli eggregori è più che mai urgente.