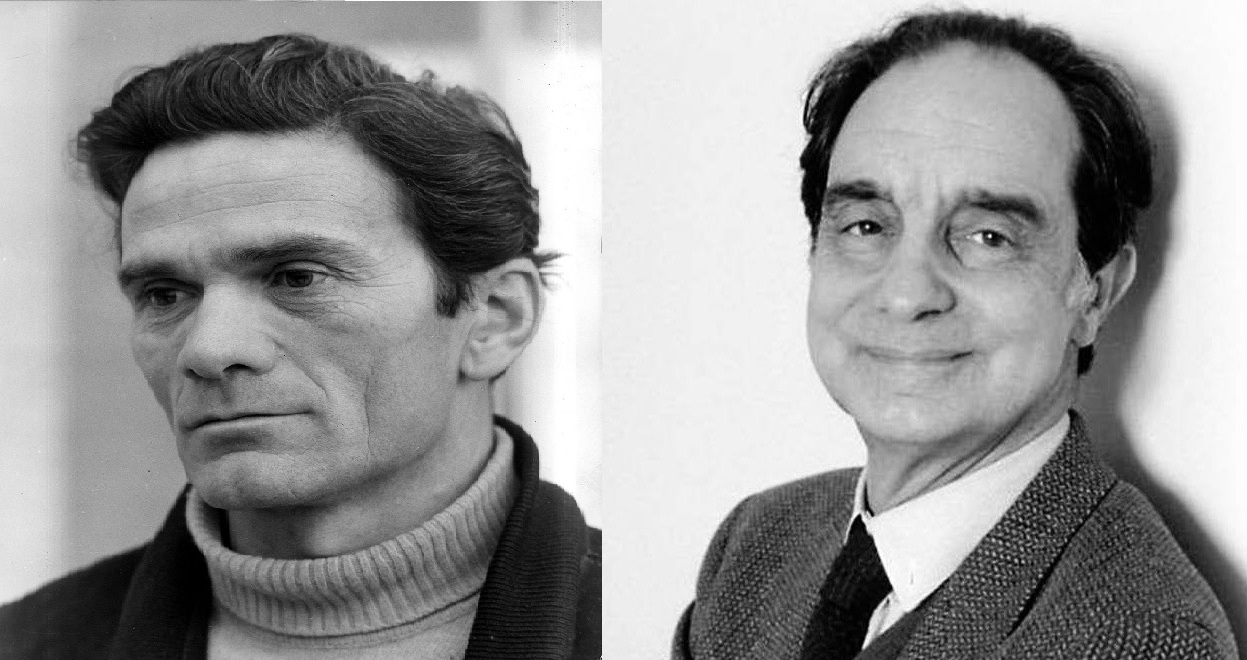Il Premio Nazionale “Caravella Tricolore 2020”, sezione “Musica”, alla sua IV edizione, è stato assegnato a Raffaele Lauro per sua articolata opera su Lucio Dalla e, in particolare, per il romanzo biografico “Caruso The Song – Lucio Dalla e Sorrento”, edito nel 2015 da GoldenGate Edizioni, dedicato al capolavoro del grande artista e al legame cinquantennale del cantautore bolognese con Sorrento, di cui era cittadino onorario e dove compose, nell’estate 1986, “Caruso”. Il prestigioso riconoscimento gli sarà consegnato, in ottobre, a Roma, nel corso di una manifestazione pubblica. Lo scrittore sorrentino, autore di diciotto romanzi di successo (www.raffaelelauro.it), ha dedicato a Dalla tre opere narrative, un tour culturale e musicale internazionale, un docufilm e il testo di una canzone dal titolo “Uno straccione, un clown”. Il romanzo premiato rappresenta un’autentica opera poetica, nell’ispirazione e nei contenuti, a partire dagli episodi legati a luoghi, a persone e a vicende di Sorrento, con il respiro onnipresente del mare. Ne viene fuori il Lucio poeta, il Lucio uomo, il Lucio cantore della Natura, con le sue passioni, con i suoi amori, con le sue solitudini, con le sue esaltazioni, con le sue melanconie e con il suo stupore fanciullo di fronte alla bellezza. E anche il suo amore per lo sport. Più che un romanzo biografico nel senso tradizionale, quindi, Lauro riesce a svelare la “biografia interiore” di Lucio Dalla: l’humanitas, la sensibilità di uomo e di artista, la capacità di dialogare con tutti e di legare umanamente con tutti. L’attitudine ad ascoltare e a “sentire” i sentimenti altrui, di recepirli e di farli suoi. In merito a quest’ultimo riconoscimento, che arricchisce una lunga serie, con l’esordio, nel 1987, del “Premio Chianciano di Narrativa Opera Prima”, fino al più recente, nel 2019, il “Premio Penisola Sorrentina – Arturo Esposito” per l’intera opera narrativa, Lauro ha dichiarato: “Sono grato agli organizzatori e alla giuria per questo riconoscimento che ricorda e celebra, mio tramite, un artista straordinario, un poeta, un musicista, un folletto lirico, il quale ha rinnovato, con ‘Caruso’, la fama di Sorrento nel mondo: una canzone-capolavoro dalla melodia immortale, che ha raccolto l’inestimabile testimone della celeberrima ‘Torna a Surriento’. Grazie, Lucio”.