“I Magi non si misero in cammino perché avevano visto la Stella, ma videro la Stella perché si erano messi in cammino”. Questa frase di Giovanni Crisostomo (344/354 – 407) racchiude una verità profonda, una chiave di lettura universale per il mistero della fede, della ricerca interiore e del rapporto tra l’uomo e il divino. Non si tratta di un semplice gioco di parole, ma di un ribaltamento del modo in cui spesso concepiamo la relazione tra segni esterni e decisioni interiori. Il cammino dei Magi, così come quello di ciascuno di noi, non inizia da una certezza, ma da una domanda, da un desiderio di andare oltre ciò che è visibile e conosciuto.
La Stella che guida i Magi verso Betlemme è, per tradizione, un segno straordinario. Un evento celeste che attrae lo sguardo di uomini sapienti, esperti di astronomia e conoscitori dei segreti della natura. Ma, secondo l’interpretazione di Giovanni Crisostomo, non è la Stella a spingere i Magi a partire, bensì il loro cuore, già teso verso una verità più grande. La Stella è un simbolo: brilla non tanto per i loro occhi, quanto per il loro spirito già disposto ad accoglierla. È una luce che si manifesta solo a chi è pronto a vederla. Questo capovolgimento ci spinge a riflettere sul senso profondo della ricerca. Non sono i segni esterni a mettere in moto il cammino, ma l’interiore necessità di trovare qualcosa che dia senso alla vita. La Stella è il riflesso visibile di una luce che già arde nell’animo di chi cerca, una luce che guida ma non impone, che invita ma non costringe.
Il viaggio dei Magi è una metafora del cammino spirituale che ciascuno di noi è chiamato a intraprendere. Non si parte mai con tutte le risposte in tasca, né con una mappa chiara e precisa. Si parte, spesso, nel buio, mossi da un’intuizione o da un desiderio che non riusciamo nemmeno a spiegare pienamente. I Magi, provenienti da terre lontane, affrontano un viaggio pieno di incognite, guidati non dalla certezza ma dalla fiducia. È un cammino che richiede il coraggio di abbandonare le proprie sicurezze: la propria terra, le proprie conoscenze, i propri punti di riferimento. Questo abbandono è un atto di fede. Si lascia ciò che è noto per inseguire l’ignoto, fidandosi di una voce interiore che sussurra che ne vale la pena. Ed è proprio in questo movimento, in questo atto di fiducia, che si manifesta il mistero della Stella: non appare prima del viaggio, ma durante il cammino, come una conferma luminosa di una scelta già compiuta.

Giovanni Crisostomo sottolinea un aspetto cruciale: la Stella non si rivela a tutti, ma solo a chi è già in cammino. Questo ci insegna che i segni del divino, le tracce della verità, non sono evidenti a chi rimane fermo, a chi aspetta che le risposte cadano dall’alto. Sono invece visibili a chi si muove, a chi cerca con cuore aperto e spirito vigile. Non si tratta di una ricerca casuale o superficiale, ma di un viaggio interiore, un cammino di trasformazione che richiede impegno, umiltà e perseveranza.
Nel mondo contemporaneo siamo spesso tentati di cercare risposte immediate, di aspettare segni evidenti che ci indichino la strada. Giovanni Crisostomo ci esorta a ribaltare questa prospettiva: non sono i segni a guidare il nostro cammino, ma è il cammino stesso che rende visibili i segni. La ricerca interiore, dunque, non è un accessorio, ma il cuore stesso della vita spirituale. È un esercizio di attenzione e di apertura, un modo per preparare il nostro spirito a riconoscere la luce quando si manifesta.
Un altro aspetto importante della questione è che la Stella non è la causa del cammino dei Magi, ma il suo coronamento. Non si tratta di un fenomeno che obbliga o che impone una direzione, ma di un segno che conferma una scelta già fatta. Ciò ci insegna che nella vita spirituale non possiamo aspettare di vedere tutto chiaramente prima di agire. Spesso le conferme arrivano solo dopo che abbiamo avuto il coraggio di muoverci, di fare il primo passo. Questo principio ha un valore universale, applicabile a ogni aspetto della nostra esistenza. Quante volte rimaniamo bloccati, incapaci di scegliere, in attesa di un segno inequivocabile? Quante volte il timore di sbagliare ci paralizza? Eppure, la lezione dei Magi ci mostra che è il movimento stesso a generare chiarezza, che è nel cammino che si trova la luce.
In un mondo caratterizzato da incertezze, ansie e continue sollecitazioni, il messaggio di Giovanni Crisostomo risuona con una straordinaria attualità. Ci induce a riscoprire il valore del cammino, dell’azione intrapresa con fede e fiducia, anche quando le direzioni non sono chiare. Non dobbiamo aspettare che tutte le risposte siano a nostra disposizione; dobbiamo invece metterci in viaggio, sapendo che la luce si manifesterà lungo la strada. Questo non significa agire in modo impulsivo o superficiale, ma coltivare un atteggiamento di apertura e di ascolto. Significa essere pronti a lasciare le nostre sicurezze, ad accogliere l’imprevisto e a credere che, anche nei momenti più bui, c’è una Stella pronta a guidarci.



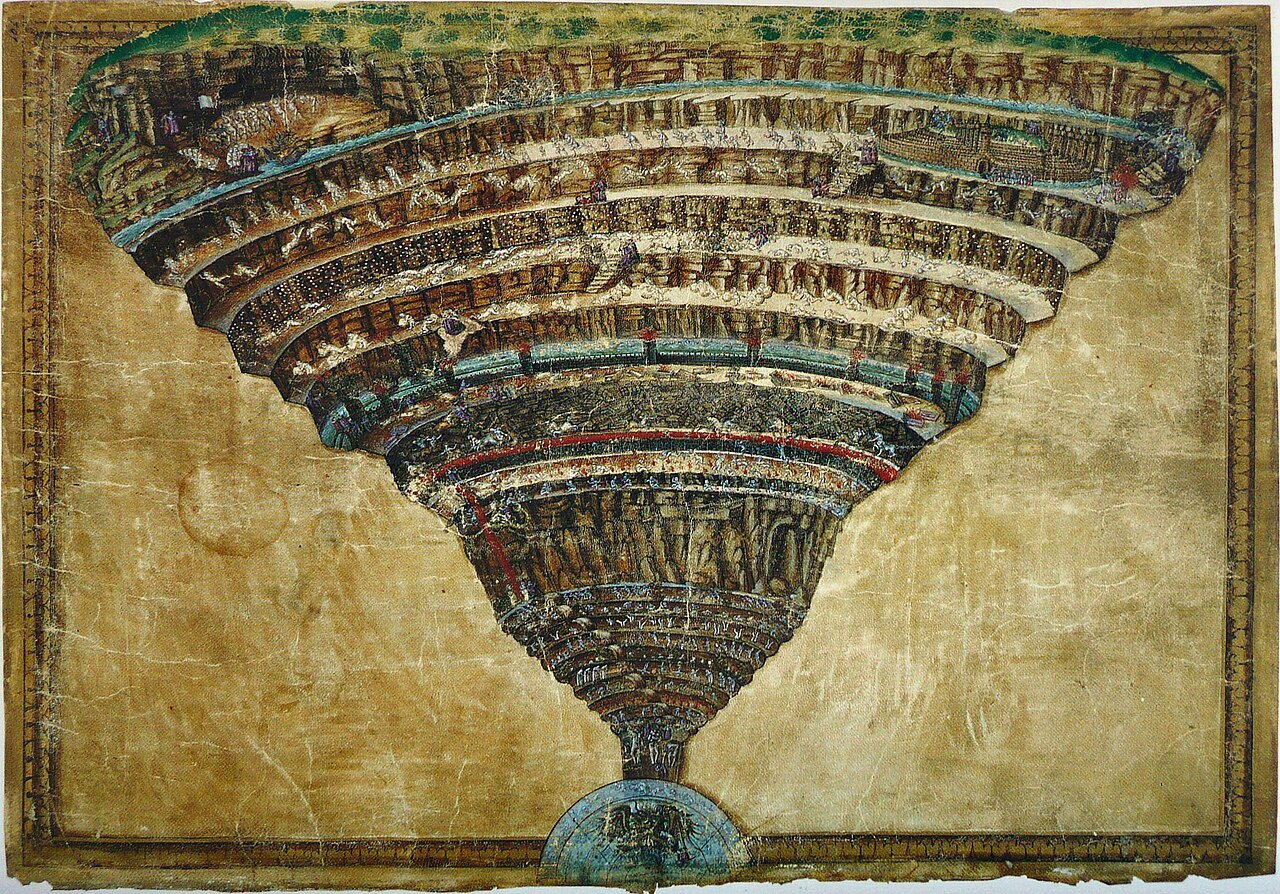




 In domestic politics, Otto I diminished the power of dukes and counts by granting public rights to bishops and abbots. He reserved the right to appoint bishops, making them pillars upon which the Kingdom of Germany rested. In foreign affairs, Otto I descended into Italy in 951 to free Adelaide from Berengar II and marry her. During this campaign, he assumed the title of King of Italy in Pavia. Subsequently, Pope John XII (955–963) sought Otto’s help against Berengar II. In 962, Otto was crowned emperor and recognized as such. On this occasion, he granted the papacy the “Privilegium Ottonianum,” reaffirming the ecclesiastical privileges from Charlemagne’s era and requiring newly elected popes to swear loyalty to the Emperor. However, John XII’s intrigues led Otto to limit papal autonomy, decreeing that no pope could be elected without his consent. John XII was deposed, and Leo VIII was elected in his place. While the papacy lost its autonomy under Otto I, this reform rescued it from the dark crisis of the “Saeculum Obscurum” (the Dark Age).
In domestic politics, Otto I diminished the power of dukes and counts by granting public rights to bishops and abbots. He reserved the right to appoint bishops, making them pillars upon which the Kingdom of Germany rested. In foreign affairs, Otto I descended into Italy in 951 to free Adelaide from Berengar II and marry her. During this campaign, he assumed the title of King of Italy in Pavia. Subsequently, Pope John XII (955–963) sought Otto’s help against Berengar II. In 962, Otto was crowned emperor and recognized as such. On this occasion, he granted the papacy the “Privilegium Ottonianum,” reaffirming the ecclesiastical privileges from Charlemagne’s era and requiring newly elected popes to swear loyalty to the Emperor. However, John XII’s intrigues led Otto to limit papal autonomy, decreeing that no pope could be elected without his consent. John XII was deposed, and Leo VIII was elected in his place. While the papacy lost its autonomy under Otto I, this reform rescued it from the dark crisis of the “Saeculum Obscurum” (the Dark Age).

