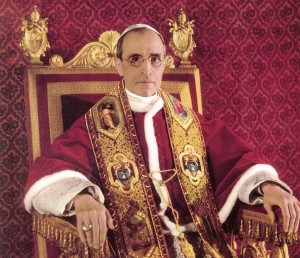Continua, con questa seconda parte (leggi la prima parte), la brevissima trattazione sul ruolo delle donne nel Risorgimento. A questo punto, dunque, è bene volgere un rapido sguardo sulle esistenze di alcune di esse, anche per riparare, in piccolissima parte, al torto commesso sia dai loro contemporanei, sia dagli storici, che le hanno confinate nel limbo della storia.
Cristina Trivulzio di Belgiojoso: milanese, ebbe una travagliata vita familiare e comportamenti, per il tempo, ritenuti scandalosi (sposata, lasciò il marito ed ebbe una figlia da un nuovo compagno). Fuggita in Francia dopo il 1831, divenne giornalista. Tornata in Italia nel 1840 si stabilì a Trivulzio. Colpita dalle condizioni di miseria dei contadini, si dedicò ai problemi sociali. Seguendo le teorie utopistiche di Henri de Saint Simon e Charles Fourier, aprì asili e scuole per figli e figlie del popolo. Nel 1848-’49 fu ancora in prima linea: raggiunse Milano guidando la Divisione Belgioioso, 200 volontari da lei reclutati e trasportati in piroscafo da Roma a Genova e, da lì, a Milano. A Roma, nei mesi della Repubblica Romana, guidata da Giuseppe Mazzini, lavorò giorno e notte negli ospedali durante l’assedio della città, creando le infermiere laiche e chiamando a questo compito nobili, borghesi e prostitute. Alla caduta della Repubblica (luglio 1849), dopo essersi battuta per salvare feriti e prigionieri, fuggì prima a Malta, poi, ad Atene e, infine, a Costantinopoli. Alla sua morte, nessuno dei politici d’Italia partecipò ai suoi funerali.
compagno). Fuggita in Francia dopo il 1831, divenne giornalista. Tornata in Italia nel 1840 si stabilì a Trivulzio. Colpita dalle condizioni di miseria dei contadini, si dedicò ai problemi sociali. Seguendo le teorie utopistiche di Henri de Saint Simon e Charles Fourier, aprì asili e scuole per figli e figlie del popolo. Nel 1848-’49 fu ancora in prima linea: raggiunse Milano guidando la Divisione Belgioioso, 200 volontari da lei reclutati e trasportati in piroscafo da Roma a Genova e, da lì, a Milano. A Roma, nei mesi della Repubblica Romana, guidata da Giuseppe Mazzini, lavorò giorno e notte negli ospedali durante l’assedio della città, creando le infermiere laiche e chiamando a questo compito nobili, borghesi e prostitute. Alla caduta della Repubblica (luglio 1849), dopo essersi battuta per salvare feriti e prigionieri, fuggì prima a Malta, poi, ad Atene e, infine, a Costantinopoli. Alla sua morte, nessuno dei politici d’Italia partecipò ai suoi funerali.
Anna Grassetti Zanardi: bolognese, fu moglie di uno degli organizzatori del tentativo  insurrezionale mazziniano di Savigno. Anch’essa ardente mazziniana, fu infermiera nel corso della campagna del 1848 e a Roma, nel 1849. Durante la successiva restaurazione pontificia, per incarico di Mazzini, si occupò di creare comitati in città e anche in altri centri vicini. Sorvegliata e più volte perquisita, fu arrestata nel 1851 e trasferita nel carcere di Ferrara. Le cronache cittadine di fine Ottocento la segnalavano, ormai vedova, sempre in testa al gruppo dei reduci garibaldini, durante i cortei patriottici, con in dosso la camicia rossa garibaldina e il petto coperto da numerose medaglie.
insurrezionale mazziniano di Savigno. Anch’essa ardente mazziniana, fu infermiera nel corso della campagna del 1848 e a Roma, nel 1849. Durante la successiva restaurazione pontificia, per incarico di Mazzini, si occupò di creare comitati in città e anche in altri centri vicini. Sorvegliata e più volte perquisita, fu arrestata nel 1851 e trasferita nel carcere di Ferrara. Le cronache cittadine di fine Ottocento la segnalavano, ormai vedova, sempre in testa al gruppo dei reduci garibaldini, durante i cortei patriottici, con in dosso la camicia rossa garibaldina e il petto coperto da numerose medaglie.
Giuditta Tavani Arquati: romana, incinta del quarto figlio, si trovava in Trastevere, nel lanificio Aiani, insieme con il marito, il figlio dodicenne e molti altri cospiratori, che preparavano la rivolta, in attesa dell’arrivo di Garibaldi da Monterotondo. L’entrata degli zuavi pontifici scatenò un aspro combattimento e, nonostante una strenua resistenza, i congiurati vennero sopraffatti e Giuditta, che aveva spronato, aiutato e soccorso i rivoltosi, venne massacrata dopo aver visto uccidere il marito e il figlio.
Sara Levi Nathan: pesarese, si profuse nell’impegno politico e per nelle iniziative sociali: fu una  fervente patriota, grande amica di Mazzini, che morì a Pisa, nel 1872, proprio a casa di sua figlia Janet. Fu sorvegliata dalla polizia e accusata di cospirazione. Riuscì a fuggire, prima di essere arrestata, e riparò a Lugano. Tornata a Roma, dette vita a numerose iniziative educative, filantropiche e sociali. Fondò, nel quartiere di Trastevere, una scuola intitolata a Mazzini, destinata alle ragazze, e aprì una casa per prostitute, l’Unione benefica, con l’intento di prevenire la prostituzione, offrendo a ragazze indigenti o in difficoltà, alloggio, mezzi e possibilità di lavoro.
fervente patriota, grande amica di Mazzini, che morì a Pisa, nel 1872, proprio a casa di sua figlia Janet. Fu sorvegliata dalla polizia e accusata di cospirazione. Riuscì a fuggire, prima di essere arrestata, e riparò a Lugano. Tornata a Roma, dette vita a numerose iniziative educative, filantropiche e sociali. Fondò, nel quartiere di Trastevere, una scuola intitolata a Mazzini, destinata alle ragazze, e aprì una casa per prostitute, l’Unione benefica, con l’intento di prevenire la prostituzione, offrendo a ragazze indigenti o in difficoltà, alloggio, mezzi e possibilità di lavoro.
Giorgina Craufurd Saffi: di famiglia inglese, si innamorò dell’Italia, anche grazie al favore che la sua famiglia esprimeva per la causa italiana. Sposò Aurelio Saffi, esule italiano a Londra, già  triumviro della Repubblica Romana nel 1849. Dalle idee mazziniane trasse il profondo interesse per l’educazione delle donne e dei giovani, cui andava inculcato il rispetto dei diritti e dei doveri dell’uomo, e l’idea che solo attraverso l’emancipazione e la partecipazione alla vita civile e civica si sarebbe potuto essere cittadini e non sudditi, partecipando, così, all’emancipazione della Patria e del Popolo. Giorgina scelse di occuparsi, in primo luogo, dell’educazione di tutte le donne, prime e fondamentali educatrici dei propri figli, cosa che la porterà ad appoggiare i movimenti emancipazionisti che, in quella seconda metà dell‘800, faticosamente stavano facendosi strada.
triumviro della Repubblica Romana nel 1849. Dalle idee mazziniane trasse il profondo interesse per l’educazione delle donne e dei giovani, cui andava inculcato il rispetto dei diritti e dei doveri dell’uomo, e l’idea che solo attraverso l’emancipazione e la partecipazione alla vita civile e civica si sarebbe potuto essere cittadini e non sudditi, partecipando, così, all’emancipazione della Patria e del Popolo. Giorgina scelse di occuparsi, in primo luogo, dell’educazione di tutte le donne, prime e fondamentali educatrici dei propri figli, cosa che la porterà ad appoggiare i movimenti emancipazionisti che, in quella seconda metà dell‘800, faticosamente stavano facendosi strada.
Adelaide Cairoli: milanese, a 18 anni sposò Carlo Cairoli, professore di chirurgia di Pavia, di sentimenti patriottici. Donna di vasta cultura, curò lei stessa l’educazione dei figli, indirizzandoli all’amore per la società e per la patria. Finanziò giornali patriottici, ospitò un salotto politico-letterario, mantenne una corrispondenza con gli intellettuali del periodo. Così scrisse, lei stessa, una volta: “Prima ancora dunque che alla causa femminile, io mi ero votata a quella della mia patria e il mio amore per la prima nacque dal mio amore per la seconda”.
Anita Ribeiro Garibaldi: fu la moglie di Giuseppe Garibaldi, nonché compagna di tutte le sue battaglie. Nel 1840, fu catturata nella battaglia di Curitibanos, ma riuscì a sfuggire alla prigionia. Nel 1849 era a Roma, per la proclamazione della Repubblica Romana, dove combatté a fianco dei garibaldini, i quali, però, dopo una lunga resistenza contro gli eserciti francese e austriaco, che invasero la città, dovettero ritirarsi dopo la battaglia del Gianicolo. Durante quella fuga le condizioni di Anita, al quinto mese di gravidanza, peggiorarono, e fu proprio in quell’occasione che, a 28 anni, la donna-guerriero spirò.