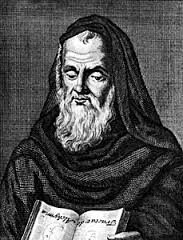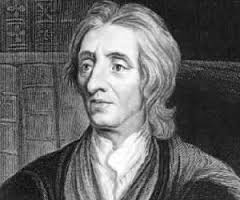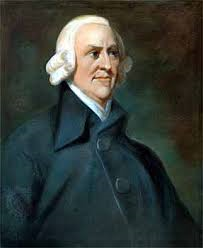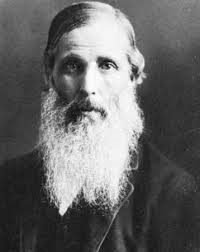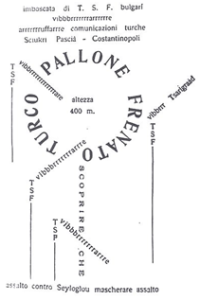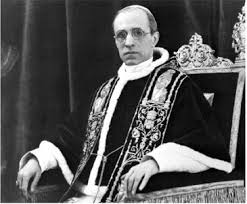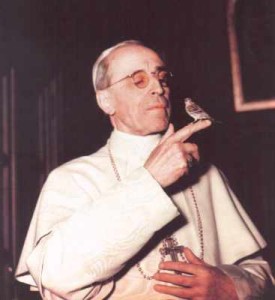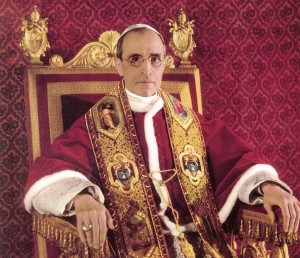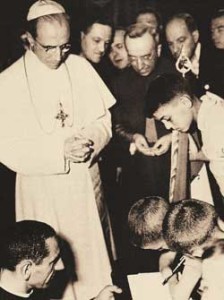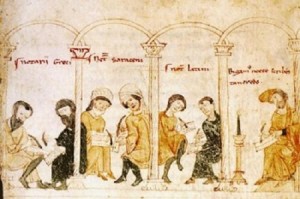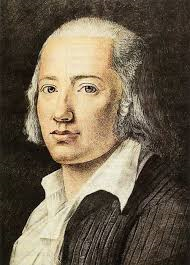È noto, pressoché unanimemente, che, nell’ambito delle azioni umane, così come, per dirla con George Hegel, negli atti degli spiriti dei popoli, si tenda a ricordare e a rimarcare quanto fatto di negativo rispetto alla strabordante quantità di positività, pure da riscontrare. E, allora, giù ad accusare, ad esempio, il filosofo Gottfried Leinbiz, di aver copiato da Isaac Newton le basi per il calcolo infinitesimale, quasi ciò fosse più importante del sistema filosofico che il primo consegnò all’umanità, o, ancora, i francesi di codardia e connivenza col nazismo, all’epoca del Regime di Vichy, quasi dimentichi di quanto fatto per la storia del pensiero universale, dalla lirica dei trovatori alle dottrine dei philosophes illuministi. Ecco, quindi, che giungo al punto, suggerito dall’argomento di questo numero della rivista: gli emigranti italiani. Bene, in qualunque paese del mondo essi abbiano messo piede, dagli Stati Uniti d’America all’Argentina, dal Canada all’Australia, hanno sempre lavorato sodo, veramente sodo, in condizioni, perlopiù, ai limiti dell’umana sopportazione, dovendo subire, sin all’arrivo, discriminazioni di varia natura, che avrebbero fatto impallidire quanti oggi giungono, in Italia, da immigrati. I nostri connazionali dei tempi passati, col proprio sudore e con le proprie rimesse economiche, contribuirono, non soltanto al miglioramento delle loro condizioni e di quelle delle loro famiglie, ma anche di quelle della nazione stessa. E, allora? Cos’è, ancora oggi, universalmente noto e tramandato dell’emigrazione italiana? La mafia. Ecco, tutto si riduce a una minima parte di italiani, che vollero disonestamente caratterizzare la loro permanenza in paesi esteri, specialmente gli Stati Uniti. Nel nostro tempo presente, in Italia, vi sono molti cittadini, i quali, per dare adito al proprio filantropismo da salotto o da PC e convincere gli altri delle loro idee, cioè flatus vocis, chiamano in causa quella subdola equazione secondo la quale noi tutti abbiamo l’obbligo morale di subire che immigrati stranieri, presenti nel nostro paese, delinquano, soltanto perché, 100 anni fa, alcuni nostri connazionali, da emigranti, fecero lo stesso nelle che li ospitavano. Questo è un atteggiamento da idioti, esiziale per il futuro della nostra nazione!
Pubblicato il 15 novembre 2016 su La Lumaca