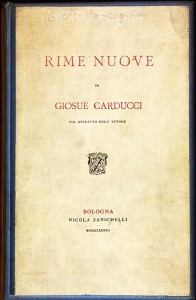Alessandro Manzoni, universalmente noto per aver scritto i Promessi Sposi, è stato anche autore di tragedie, che hanno rivoluzionato la struttura classica di questo particolare genere teatrale. Il letterato milanese avrebbe fatto molto arrabbiare Aristotele, massima autorità del campo, se quest’ultimo avesse potuto leggere le sue due opere drammatiche, “Il conte di Carmagnola” (1820) e “Adelchi” (1822), perché, in esse, le unità di tempo, di luogo e d’azione, come teorizzate dal filosofo greco nella Poetica e sulle quali era strutturata la tragedia greca classica, non sono assolutamente prese in considerazione. Aristotele, infatti, sosteneva che la rappresentazione tragica dovesse svolgersi nello stesso luogo e, al massimo, in due giorni. L’esposizione degli antefatti e di altre eventuali chiarificazioni sarebbero state compito del coro che avrebbe, così, informato gli spettatori. Manzoni, in barba al Filosofo, impiega sette anni per far morire il conte di Carmagnola e tre per Adelchi; situa le azioni in campi coltivati e campi di battaglia, nel palazzo del Senato Veneto per la prima tragedia e nell’accampamento di Carlo Magno, nella reggia del re Desiderio e nel convento dove langue Ermangarda per la seconda. All’Autore, evidentemente, interessava dimostrare altro, non la sua bravura ad accordarsi ad un modello che aveva fatto scuola per più di 2000 anni, quanto dar voce a virtù, atteggiamenti e modi di fare, passioni pure e rovinose, azioni spregiudicate, drammi interiori e collettivi, da lui descritti in modo impareggiabile e profondo, spesso velando riferimenti all’Italia del suo tempo. In più, sempre contro la lezione di Aristotele, adoperò i cori per esprimere, in versi, le sue personali riflessioni e il suo punto di vista, tanto che questi potrebbero essere eliminati dal dramma, senza impedirne la comprensione dello sviluppo. Anche nelle antologie scolastiche, infatti, sono i cori, anziché le restanti parti delle tragedie, ad essere solitamente letti e studiati. Capita, non di rado, che gli studenti ne confondano i versi con poesie indipendenti, piuttosto che considerarli parti di opere composte, comunque, più per la lettura che per la rappresentazione a teatro.
Alessandro Manzoni, universalmente noto per aver scritto i Promessi Sposi, è stato anche autore di tragedie, che hanno rivoluzionato la struttura classica di questo particolare genere teatrale. Il letterato milanese avrebbe fatto molto arrabbiare Aristotele, massima autorità del campo, se quest’ultimo avesse potuto leggere le sue due opere drammatiche, “Il conte di Carmagnola” (1820) e “Adelchi” (1822), perché, in esse, le unità di tempo, di luogo e d’azione, come teorizzate dal filosofo greco nella Poetica e sulle quali era strutturata la tragedia greca classica, non sono assolutamente prese in considerazione. Aristotele, infatti, sosteneva che la rappresentazione tragica dovesse svolgersi nello stesso luogo e, al massimo, in due giorni. L’esposizione degli antefatti e di altre eventuali chiarificazioni sarebbero state compito del coro che avrebbe, così, informato gli spettatori. Manzoni, in barba al Filosofo, impiega sette anni per far morire il conte di Carmagnola e tre per Adelchi; situa le azioni in campi coltivati e campi di battaglia, nel palazzo del Senato Veneto per la prima tragedia e nell’accampamento di Carlo Magno, nella reggia del re Desiderio e nel convento dove langue Ermangarda per la seconda. All’Autore, evidentemente, interessava dimostrare altro, non la sua bravura ad accordarsi ad un modello che aveva fatto scuola per più di 2000 anni, quanto dar voce a virtù, atteggiamenti e modi di fare, passioni pure e rovinose, azioni spregiudicate, drammi interiori e collettivi, da lui descritti in modo impareggiabile e profondo, spesso velando riferimenti all’Italia del suo tempo. In più, sempre contro la lezione di Aristotele, adoperò i cori per esprimere, in versi, le sue personali riflessioni e il suo punto di vista, tanto che questi potrebbero essere eliminati dal dramma, senza impedirne la comprensione dello sviluppo. Anche nelle antologie scolastiche, infatti, sono i cori, anziché le restanti parti delle tragedie, ad essere solitamente letti e studiati. Capita, non di rado, che gli studenti ne confondano i versi con poesie indipendenti, piuttosto che considerarli parti di opere composte, comunque, più per la lettura che per la rappresentazione a teatro.
Il conte di Carmagnola
Francesco Bussone è un contadino di Carmagnola che diventa soldato di ventura e mercenario al servizio del duca di Milano, Filippo Maria Visconti.  La sua abilità con le armi gli permette una brillante carriera, culminante con la nomina a conte e col matrimonio con la figlia del suo signore. L’invidia dei colleghi, la quale è sempre stata una malattia vecchia come il mondo, fa sì che questi riescano a convincere il duca a cacciarlo da Milano. Il conte di Carmagnola non si perde d’animo e va al servizio dei Veneziani, che stanno preparando la guerra ai milanesi. Valoroso in battaglia come al solito, sbaraglia le truppe meneghine a Maclodio ma non fa rincorrere, per fare prigionieri, i nemici che si erano ritirati e neppure avanza per sfruttare la vittoria. Tutto questo viene considerato un tradimento dal Senato Veneziano che, attiratolo con una scusa a Venezia, lo processa e condanna a morte. L’Autore intende dimostrare come un uomo dallo spirito nobile e generoso, giunto all’apice del successo personale e del potere, possa, poi, cadere in disgrazia, travolto dalla forza malvagia che governa il mondo, trovando, infine, conforto nella fede cristiana.
La sua abilità con le armi gli permette una brillante carriera, culminante con la nomina a conte e col matrimonio con la figlia del suo signore. L’invidia dei colleghi, la quale è sempre stata una malattia vecchia come il mondo, fa sì che questi riescano a convincere il duca a cacciarlo da Milano. Il conte di Carmagnola non si perde d’animo e va al servizio dei Veneziani, che stanno preparando la guerra ai milanesi. Valoroso in battaglia come al solito, sbaraglia le truppe meneghine a Maclodio ma non fa rincorrere, per fare prigionieri, i nemici che si erano ritirati e neppure avanza per sfruttare la vittoria. Tutto questo viene considerato un tradimento dal Senato Veneziano che, attiratolo con una scusa a Venezia, lo processa e condanna a morte. L’Autore intende dimostrare come un uomo dallo spirito nobile e generoso, giunto all’apice del successo personale e del potere, possa, poi, cadere in disgrazia, travolto dalla forza malvagia che governa il mondo, trovando, infine, conforto nella fede cristiana.
Adelchi
Ermengarda, moglie ripudiata da Carlo Magno, torna a Pavia dal padre Desiderio, re dei Longobardi. Questi, avendo invaso i territori del papato, ora alleato dei Franchi, e non avendo dato seguito all’ultimatum di Carlo, che gli intimava di ritirarsi, gli dichiara guerra. Ermengarda si reca dalla sorella badessa di un convento a Brescia. Qui, sapute delle nuove nozze del suo ancora amato Carlo, muore per il dispiacere. A questo punto, il famosissimo canto del coro, meglio noto come “La morte di Ermengarda“:
“Sparsa le trecce morbide
sull’affannoso petto,
lenta le palme, e rorida
di morte il bianco aspetto,
giace la pia, col tremolo
sguardo cercando il ciel“.
(Adelchi, Atto IV, scena I, vv. 1 – 6)
L’esercito franco, intanto, grazie alla spia di un traditore longobardo, riesce a valicare le Alpi, attraverso un passaggio non difeso, giungendo a Verona. Adelchi, il quale si era sempre opposto alla guerra, ma che niente aveva potuto contro il fermo volere del padre, viene ferito gravemente in battaglia ed è portato nella tenda di Carlo, dove si trova pure Desiderio, fatto prigioniero. Muore tra le braccia del padre.
Adelchi: “O Re de’ re tradito
da un tuo Fedel, dagli altri abbandonato!…
Vengo alla pace tua: l’anima stanca
accogli”.
Desiderio: “Ei t’ode: oh ciel! tu manchi! ed io…
In servitude a piangerti rimango“.
(Adelchi, Atto V, scena X, vv. 6-11)
L’Adelchi è, innanzitutto, la tragedia della lotta dei personaggi contro i propri sentimenti. Bellissima la figura di Ermengarda, la quale, seppure ripudiata, vittima sacrificale della ragion di Stato, prova ancora forte e delicata passione per Carlo. Allo stesso modo, Adelchi, il quale, sottomesso alla volontà del padre, combatte, con valore, una guerra ingiusta e senza speranza di vittoria, trovandovi la morte. Chiaro è anche il contributo che Manzoni, con quest’opera, volle dare al risveglio degli italiani del Risorgimento. L’Adelchi, infatti, rappresenta il dramma di tre popoli: il longobardo in fuga, il franco vincitore, a prezzo, però, di grandi sacrifici, e l’italico, da sempre diviso, nell’illusione di poter riacquistare la libertà grazie agli stranieri i quali, invece, lo dominano ferocemente. L’indipendenza, secondo il futuro senatore del Regno d’Italia, sarebbe potuta essere conquistata soltanto se il popolo italiano si fosse unito e disposto a combattere qualunque invasore straniero.