Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), filosofo, oratore e uomo di Stato, elaborò una teoria politica che si fonda sulla centralità della legge, sulla difesa della libertas e sulla necessità di un governo misto come garanzia di stabilità. Il suo pensiero, profondamente influenzato dalla filosofia greca, in particolare da Platone, Aristotele e dagli Stoici, ebbe un impatto duraturo sulla tradizione politica occidentale, ispirando filosofi e giuristi fino all’età moderna.
Cicerone concepiva la res publica come un bene comune, non di proprietà di un singolo individuo o di una classe, ma di tutti i cittadini. La sua idea di Stato non si basa su un contratto sociale esplicito, ma sulla convinzione che l’ordinamento politico debba essere conforme alla natura razionale dell’uomo e mirare al bene della collettività. In questo senso, Cicerone sviluppa un’idea di giustizia politica che lega il governo alla moralità e alla virtù dei cittadini e dei governanti.
Secondo Cicerone, la miglior forma di governo è quella che combina elementi della monarchia, dell’aristocrazia e della democrazia, evitando gli estremi delle forme degenerative (tirannia, oligarchia e demagogia). Questo principio, ispirato alla teoria del governo misto di Polibio, si riflette nella struttura politica della Repubblica romana, in cui i consoli rappresentavano il potere monarchico, il Senato quello aristocratico e i comizi popolari quello democratico. Tale equilibrio era per Cicerone essenziale per la stabilità dello Stato e per evitare il rischio della corruzione o della tirannide.
Uno dei concetti cardine del pensiero politico di Cicerone è la supremazia della legge. Egli sostiene che la legge non è una semplice convenzione umana, ma un principio universale, radicato nella natura razionale dell’uomo. Questo lo avvicina alla dottrina stoica del diritto naturale, secondo cui esiste una legge morale eterna e immutabile che precede e vincola le leggi positive create dagli uomini.

Nel De Legibus, Cicerone afferma che “la legge è la più alta ragione insita nella natura”, sottolineando che il diritto positivo deve essere conforme a questa legge superiore. Il potere politico, dunque, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto della giustizia. Questo principio anticipa concetti fondamentali del pensiero giuridico moderno, come il costituzionalismo e la separazione tra diritto e potere.
Per Cicerone, il buon governo dipende non solo dalla struttura delle istituzioni, ma anche dalla virtù e dall’impegno dei cittadini. La libertas non è solo assenza di oppressione, ma anche partecipazione attiva alla vita pubblica. Il cittadino virtuoso deve essere moralmente integro e capace di mettere il bene comune al di sopra degli interessi personali. In questo contesto, Cicerone assegna un ruolo centrale all’oratore, figura che incarna il perfetto uomo politico. L’oratoria non è solo un’arte tecnica di persuasione, ma uno strumento per difendere la giustizia e guidare il popolo. Nel De Oratore, sottolinea che il vero oratore deve essere anche un filosofo, capace di discernere il giusto dall’ingiusto e di educare i cittadini alla virtù.
Uno degli aspetti più rilevanti del pensiero politico ciceroniano è la critica alla tirannide. Per Cicerone, il governo di un solo uomo privo di vincoli legali rappresenta la più grave minaccia per la libertas e per la stabilità della res publica. La libertà non è solo l’assenza di dominio arbitrario, ma un sistema in cui il potere è bilanciato e regolato dalla legge. La sua opposizione a Giulio Cesare e successivamente a Marco Antonio ne è una dimostrazione concreta. Cicerone vedeva in Cesare un pericolo per la Repubblica, poiché con la sua ascesa al potere assoluto minava l’equilibrio istituzionale. Dopo l’uccisione di Cesare, tentò di contrastare Marco Antonio con le celebri Filippiche, discorsi in cui lo accusava di aspirare alla tirannide. Questa strenua difesa della Repubblica gli costò la vita: fu proscritto e assassinato nel 43 a.C.
L’influenza del pensiero politico di Cicerone si estese ben oltre la sua epoca. Durante il Medioevo, il suo concetto di diritto naturale venne integrato nella filosofia scolastica, soprattutto grazie a Tommaso d’Aquino. Nel Rinascimento, il recupero delle sue opere contribuì a rinnovare l’interesse per la politica e il diritto. Nell’età moderna, pensatori come John Locke e Montesquieu ripresero i suoi concetti di legge naturale e governo misto per sviluppare le loro teorie sul costituzionalismo e sulla separazione dei poteri. La sua concezione della libertas influenzò profondamente il pensiero repubblicano e contribuì alla formulazione delle moderne democrazie costituzionali. Cicerone non fu solo un teorico della politica, ma un uomo d’azione che visse coerentemente con le sue idee, difendendo la Repubblica fino alla fine. Il suo pensiero resta un punto di riferimento fondamentale per chi riflette sul rapporto tra legge, libertà e potere.

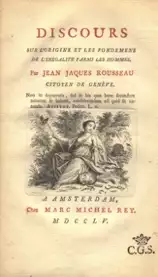 Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.
Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.