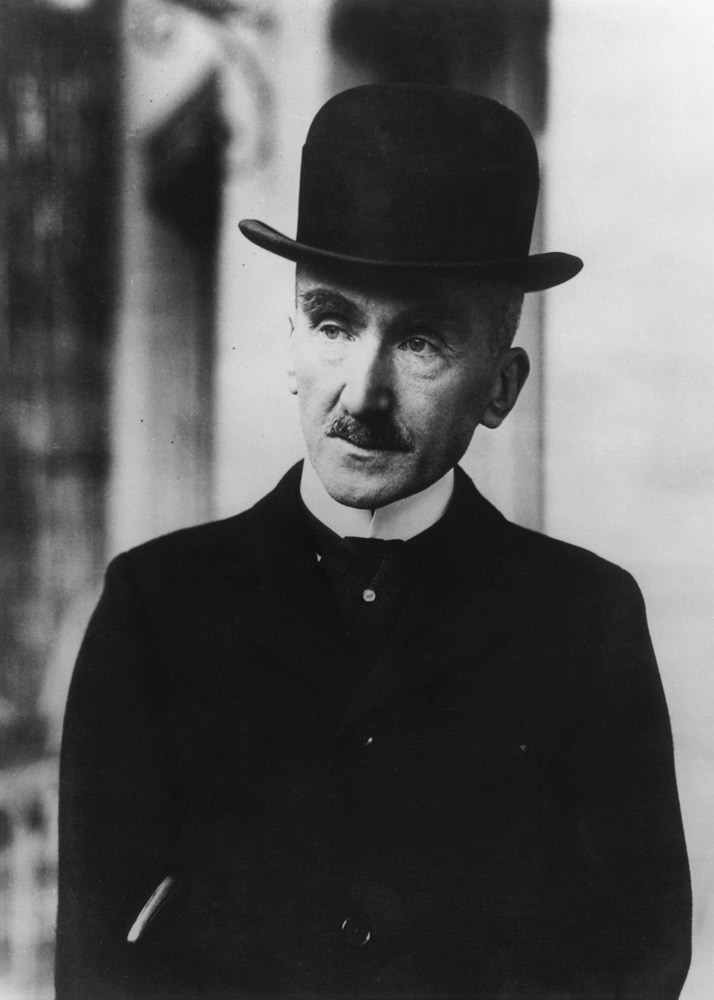Melisso di Samo (V secolo a.C.) è stato uno dei principali esponenti della scuola eleatica, seguace di Parmenide e contemporaneo di Zenone. La sua riflessione filosofica si concentra sull’essere e sulla sua natura, sviluppando e ampliando le intuizioni di Parmenide con alcune differenze significative. Egli è noto soprattutto per il suo tentativo di dimostrare razionalmente che l’essere è unico, eterno, immutabile e infinito.
Melisso riprende l’idea parmenidea secondo cui l’essere è uno e non può derivare dal nulla né dissolversi nel nulla. Tuttavia, a differenza di Parmenide, che concepiva l’essere come finito e sferico, Melisso sostiene che esso debba essere infinito. Egli giustifica questa affermazione con il seguente ragionamento: se l’essere fosse finito, dovrebbe avere un limite, ma ciò implicherebbe la presenza di qualcosa al di là di esso, il che sarebbe una contraddizione, poiché nulla può esistere al di fuori dell’essere.
Questa concezione dell’infinità dell’essere rappresenta un significativo sviluppo rispetto alla visione di Parmenide e introduce un elemento che influenzerà alcune correnti successive del pensiero filosofico, come il neoplatonismo.
Melisso afferma con forza che l’essere è immutabile e che ogni forma di mutamento o di diversità è un’illusione. La sua argomentazione si basa sul principio di non contraddizione: se l’essere cambiasse, significherebbe che una parte di esso diventerebbe non-essere, il che è logicamente impossibile. Quindi, tutto ciò che appare come trasformazione, nascita o distruzione è solo un inganno dei sensi. Questo porta Melisso a negare la realtà del divenire e del tempo stesso: se l’essere è eterno e immutabile, il tempo non può esistere come qualcosa di reale, ma è solo un’illusione della percezione umana.

Un altro punto chiave della filosofia di Melisso è la negazione del vuoto. Egli sostiene che il vuoto non può esistere, poiché ciò equivarrebbe a postulare la presenza del non-essere, il che è impossibile. Senza il vuoto, però, il movimento non è possibile, poiché il movimento richiede uno spazio libero in cui potersi realizzare. Questa conclusione si oppone frontalmente alle teorie atomistiche di Leucippo e Democrito, i quali sostenevano che il movimento e la diversità della realtà derivassero dall’esistenza del vuoto tra gli atomi. Il rifiuto del vuoto da parte di Melisso si allinea invece con la tradizione eleatica, rafforzando l’idea dell’essere come un tutto continuo e senza divisioni.
La filosofia di Melisso ha avuto un impatto significativo nella storia del pensiero, anche se è stata oggetto di numerose critiche. Aristotele, ad esempio, lo accusa di commettere errori logici nelle sue dimostrazioni e di trarre conclusioni che non tengono conto dell’esperienza sensibile. Tuttavia, le sue riflessioni sulla natura dell’essere hanno contribuito a plasmare il dibattito metafisico nei secoli successivi.
Platone e Aristotele, pur criticandolo, non possono ignorarne il rigore logico e le implicazioni del suo pensiero. La sua visione di un essere eterno e immutabile influenzerà anche lo stoicismo e alcune correnti del neoplatonismo, in particolare per quanto riguarda l’idea di un principio unico e assoluto che governa la realtà.
Melisso di Samo rappresenta un’estensione radicale della filosofia eleatica, portando alle estreme conseguenze le idee di Parmenide. La sua concezione dell’essere come infinito e immutabile, il rifiuto del vuoto e del movimento, e la negazione del tempo fanno della sua filosofia una delle più rigorose espressioni del monismo ontologico. Sebbene la sua visione sia stata superata dalle teorie pluraliste e dinamiche del mondo naturale, il suo contributo rimane essenziale per la storia della metafisica. Le sue argomentazioni hanno costretto i filosofi successivi a confrontarsi con il problema dell’essere e del divenire, dando impulso a nuove sintesi e sviluppi nel pensiero occidentale.